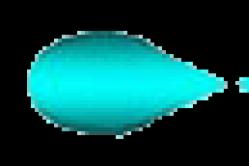Gli antipiretici per i bambini sono prescritti da un pediatra. Ma ci sono situazioni di emergenza con la febbre in cui il bambino ha bisogno di ricevere immediatamente medicine. Quindi i genitori si assumono la responsabilità e usano farmaci antipiretici. Cosa è consentito dare ai neonati? Come abbassare la temperatura nei bambini più grandi? Quali farmaci sono i più sicuri?
Quante lingue ci sono nel mondo? Si ritiene che da 2500 a 7000. Le opinioni degli scienziati sul loro numero totale differiscono a causa della mancanza di un approccio unificato a cosa è considerato una lingua e cosa è un dialetto.
Quante lingue ci sono nel mondo?
Tutte le lingue del mondo sono divise in famiglie, di cui ce ne sono 240. Il gruppo più numeroso e di gran lunga più studiato è considerato il gruppo indoeuropeo, che comprende la lingua russa. La base per includere lingue diverse in una famiglia è la significativa somiglianza fonetica dei concetti di base che denotano e la somiglianza della struttura grammaticale.
Esistono anche lingue isolate che non possono essere collocate in nessuna famiglia. Un esempio di una lingua così isolata, "che non ricorda la parentela", è il dialetto basco "Euskera".
Lingue più comuni
Quante sono le lingue più diffuse nel mondo moderno? Questi includono 10: cinese (mandarino), inglese, spagnolo, russo, hindi, arabo, bengalese, portoghese, malese-indonesiano, francese. Il mandarino è parlato da oltre 1 miliardo di persone. Ognuna delle altre nove lingue tra le dieci più comuni è parlata da oltre 100 milioni di persone.
La ragione della popolarità della lingua cinese dovrebbe essere considerata il fatto che è parlata in Cina, Singapore, Taiwan, ci sono grandi diaspore cinesi in quasi tutti i paesi del sud-est asiatico e in altri paesi del mondo. Non dobbiamo dimenticare la fertilità di questo popolo.

I madrelingua inglesi furono i conquistatori più attivi delle terre d'oltremare e gli scopritori delle Americhe. Ecco perché, se guardiamo la mappa linguistica del mondo, vedremo che queste due lingue dominano territorialmente. L'inglese è la lingua ufficiale in 56 – più di 20 paesi. Anche i francesi, proprio come gli inglesi e gli spagnoli, crearono un tempo un potente impero che controllava vasti territori nel Nord America e in Africa. Oggi il francese è la prima lingua ufficiale in 15 paesi del mondo.
Nella storia della civiltà europea, diverse lingue nel mondo in tempi diversi hanno occupato la posizione di lingua franca interetnica. Durante l'Impero Romano, la Koine, la lingua greca comune, divenne la lingua franca del Mediterraneo orientale e dell'antico Vicino Oriente. Successivamente, per più di 1000 anni, prima nei paesi del Mediterraneo e poi in tutta l’Europa cattolica, il latino fu utilizzato come lingua franca. Nei secoli XVIII-XIX, il francese divenne il mezzo di comunicazione internazionale. Dalla fine del ventesimo secolo, l'inglese è diventato il mezzo di comunicazione interetnica in tutto il mondo, senza dubbio grazie alla posizione di leader nel mondo della superpotenza di lingua inglese: gli Stati Uniti.

Lingue morte
In linguistica esiste una cosa come una “lingua morta”. Questa è una lingua che non si parla più, e che si conosce solo grazie ai monumenti scritti. In alcuni casi, le lingue morte continuano a vivere perché utilizzate per scopi scientifici o religiosi. Quante lingue ci sono nel mondo? Tra questi vi è il latino, da cui si sono successivamente sviluppate le lingue romanze; Il russo antico, che divenne la base per le lingue slave orientali, e il greco antico. Esistono anche numerose lingue morte utilizzate per scopi scientifici e religiosi: sanscrito, copto, avestico.
C'è un caso unico di resurrezione di una lingua morta. Dopo la seconda guerra mondiale, con la creazione dello Stato d'Israele, l'ebraico, che non veniva più parlato da 18 secoli, è tornato a essere la lingua ufficiale del paese.
Lingua dominante
In un ambiente bilingue, una lingua è dominante. In precedenza, durante i tempi degli imperi, la ragione principale della morte delle lingue locali era lo sterminio di massa della popolazione locale. Oggi, una lingua più debole muore per ragioni socioeconomiche, non perché i suoi parlanti stanno scomparendo. L'ignoranza della lingua dominante comporta l'impossibilità di ottenere un'istruzione, di salire nella scala sociale, ecc. Pertanto, in una famiglia bilingue, i genitori spesso preferiscono non parlare nemmeno la loro lingua madre in via di estinzione, per non creare problemi ai propri figli in il futuro. Il processo di estinzione è fortemente influenzato dai media che utilizzano il linguaggio dominante.
Una domanda importante è quante lingue ci sono nel mondo. Ma un problema ancora più importante è la loro estinzione. Ogni 2 settimane, una lingua scompare nel mondo. Secondo gli scienziati, entro la fine del 21° secolo, ne scompariranno 3,5mila.

Lingue costruite
Un fenomeno interessante nel mondo delle lingue sono i dialetti artificiali. Quante lingue di questo tipo esistono nel mondo? Ce ne sono 16 e il più popolare è l'esperanto, creato nel 1887 da Ludwig Zamenhof. Zamenhof era originario di Bialystok, una città dove vivevano ebrei, polacchi, tedeschi e bielorussi. La città era molto complessa e Zamenhof riteneva che la ragione di ciò fosse la mancanza di una lingua comune. Lo scopo dell'esperanto era diffondere idee di convivenza pacifica tra le persone di tutto il mondo. Zamenhof ha pubblicato un libro di testo in esperanto. Tradusse molti capolavori della letteratura mondiale nella sua lingua e scrisse persino poesie in esperanto. La maggior parte del vocabolario dell'esperanto è costituito da radici romanze e germaniche, nonché da latino e greco, che hanno un significato scientifico generale. Su Wikipedia sono stati pubblicati circa 200.000 articoli in esperanto.
Adesso sai quante lingue ci sono nel mondo, e forse puoi salvare quelle in via di estinzione studiandole.
Sapevi che la lingua più popolare al mondo è parlata da 1/7 della popolazione mondiale? E questo non è affatto inglese! Esistono più di 7.000 lingue nel mondo, ma 10 di queste sono le più popolari. C'è il russo in questa top ten? La risposta è sotto il taglio...
N. 10 francese - 150 milioni di parlanti
Il francese è parlato in 53 paesi del mondo, il principale dei quali è la Francia. Circa 150 milioni di parlanti nel mondo. Il francese è la lingua ufficiale di numerose organizzazioni internazionali: Unione Europea, Comitato Olimpico Internazionale, ONU, ecc.

N. 9. Lingua indonesiana: 200 milioni di parlanti
L'indonesiano è parlato in 16 paesi, inclusa l'Indonesia, e ha lo status di lingua di lavoro a Timor Est. L'Indonesia è uno stato insulare con più di 13mila isole.
La lingua indonesiana si è evoluta dal malese nel 20° secolo ed è il dialetto più parlato della lingua malese.

N. 8. Lingua portoghese: 240 milioni di parlanti
Il portoghese è parlato in 12 paesi del mondo. Il portoghese è la lingua ufficiale del Brasile.
Nel XII secolo il Portogallo divenne indipendente dalla Spagna ed espanse i suoi possedimenti in tutto il mondo grazie ai marittimi. Avendo fondato colonie in Brasile, Angola, Macao, Mozambico, Venezuela e altri paesi, i portoghesi hanno reso la loro lingua una delle lingue più diffuse al mondo. Il portoghese è una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea e di altre organizzazioni internazionali.

N. 7. Lingua bengalese: 250 milioni di parlanti
Il bengalese è parlato in Bangladesh e in alcuni stati dell'India. Per il Bangladesh, il bengalese è la lingua ufficiale, mentre per l'India è la seconda lingua più popolare.

N. 6. Russo: 260 milioni di parlanti
Il russo è parlato in 17 paesi del mondo. Il russo è la lingua ufficiale di Russia, Kazakistan, Bielorussia, Kirghizistan e Tagikistan. Ampiamente distribuito in Ucraina, Lettonia ed Estonia. In misura minore nei paesi che facevano parte dell’Unione Sovietica.
Il russo è una delle sei lingue ufficiali dell'ONU, la lingua più parlata in Europa e la lingua slava più parlata nel mondo.

N. 5. Arabo: 267 milioni di parlanti
L'arabo è parlato in 58 paesi del mondo. Il maggior numero di parlanti arabi è concentrato in Arabia Saudita, Iraq, Kuwait, Siria, Libano, Giordania ed Egitto.
La lingua araba si sta diffondendo in tutto il mondo anche grazie al libro principale dei musulmani: il Corano. L’arabo è diventata la sesta lingua ufficiale delle Nazioni Unite nel 1974.

N. 4. Spagnolo: 427 milioni di madrelingua
Lo spagnolo è parlato in 31 paesi del mondo. La lingua spagnola ha origine in Spagna nel Medioevo e si diffonde in tutto il mondo durante le Grandi Scoperte Geografiche. Lo spagnolo è la lingua ufficiale delle organizzazioni internazionali: ONU, Unione Europea, Unione delle Nazioni Sudamericane, ecc.

Numero 3. Hindi: 490 milioni di parlanti
L'hindi è parlato in India, Nepal, Bangladesh e Pakistan.
Molti prevedono che presto l’hindi diventerà la lingua più parlata al mondo, superando la Cina, ma quando e se ciò accadrà resta sconosciuto.

N. 2. Lingua inglese: 600 milioni di madrelingua
L'inglese è la lingua più parlata al mondo in termini di numero di paesi che copre: 106 paesi. L'inglese è la lingua ufficiale e principale in Gran Bretagna. Paesi come India, Irlanda, Nuova Zelanda, Canada e Filippine usano l'inglese come lingua ufficiale, ma oltre ad esso hanno anche le proprie lingue ufficiali.

N. 1. Lingua cinese: 1,3 miliardi di parlanti
Il cinese è la lingua ufficiale della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e di Singapore. È parlata da oltre 1,3 miliardi di persone in tutto il mondo e quindi è al primo posto nella lista delle lingue più parlate al mondo.
Il cinese è considerata la lingua più difficile del mondo. Il cinese è una delle sei lingue ufficiali dell'ONU.

Introduzione. 3
I. Capitolo. La formazione della geografia linguistica. 6
1.1. Storia della nascita e dello sviluppo della geografia linguistica in Europa. Concetti di base di questa scienza. 6
1.2. Sviluppo della geografia linguistica in Russia. Mappatura dei fenomeni linguistici. 13
1.3. Divisione dialettale della lingua russa. 23
Conclusioni per il capitolo 1. trenta
Capitolo II. Linguistica areale. 32
1.1. Il concetto di “linguistica areale” e le sue caratteristiche. 32
2.2. Area storico-culturale: concetto e principi della sua distribuzione 34
Conclusioni sul capitolo 2. 47
Conclusione. 49
Riferimenti... 53
introduzione
La geografia linguistica è una branca della linguistica che studia la distribuzione territoriale dei fenomeni linguistici. La geografia linguistica è emersa nel XIX secolo. dalla dialettologia. L'accumulo di dati sulla presenza di differenze dialettali nelle diverse lingue ha sollevato il problema della coincidenza o non coincidenza dei confini della distribuzione di tali differenze in un determinato territorio linguistico. La geografia linguistica è strettamente correlata alla linguistica areale. Il trasferimento dei dati sulle caratteristiche di alcune formazioni su una carta geografica ha mostrato che la loro distribuzione nel territorio occupato da una lingua forma un complesso intreccio di isoglosse (linee su una carta geografica che limitano la distribuzione territoriale di un particolare fatto linguistico), e solitamente di isoglosse di i diversi fenomeni caratteristici di questo dialetto non coincidono. Tuttavia, senza coincidere del tutto, le singole isoglosse passano l'una accanto all'altra, formando i cosiddetti fasci di isoglosse, tra i quali si distinguono territori, caratterizzati da unità linguistica secondo i fenomeni di un dato fascio e formando dialetti territoriali. L'insieme delle isoglosse presenti nel territorio di distribuzione di una determinata lingua, o “paesaggio linguistico”, è oggetto di studio della geografia linguistica.
L'emergere e lo sviluppo della geografia linguistica sono associati alla mappatura delle differenze dialettali tra le lingue e alla creazione di atlanti dialettologici. Tali atlanti possono essere diversi: atlanti di singoli territori, di una lingua, gruppi di lingue correlate, atlanti che coprono territori in cui si trovano lingue di sistemi diversi, ecc. Gli atlanti differiscono nel materiale cartografico, nel grado in cui le caratteristiche del dialetto si riflettono sulle mappe a diversi livelli del sistema linguistico, in relazione e riflessione dei processi storici nello sviluppo dei dialetti di una determinata lingua, ecc.
La geografia linguistica consente, sulla base di uno studio comparativo delle isoglosse, di ottenere informazioni importanti per lo studio retrospettivo della storia delle lingue e dei dialetti, per stabilirne le connessioni, la relativa cronologia nello sviluppo di alcuni fenomeni linguistici. Interpretando la natura delle isoglosse, la loro direzione e la loro relazione reciproca, i ricercatori sono in grado di utilizzare la ricostruzione interna dei fenomeni linguistici e il loro confronto con i dati della storia dei parlanti dialettali per ricostruire le modalità di sviluppo di una lingua popolare vivente nella sua diversità dialettale. Lo studio con metodi di geografia linguistica di gruppi di lingue correlate e il paesaggio linguistico dei territori di distribuzione delle lingue di diversi sistemi aiuta a studiare la storia dello sviluppo e dell'interazione di interi popoli, delle loro lingue e culture . Nella seconda metà del 20 ° secolo. In molti paesi sono apparsi atlanti linguistici delle lingue nazionali o delle singole regioni della loro distribuzione.
Pertinenza dell'argomento è dovuto al fatto che in questa fase di sviluppo della linguistica, la registrazione e il successivo studio di varie caratteristiche dei fenomeni linguistici moderni, le loro differenze nelle diverse regioni della lingua russa, acquisiscono grande importanza.
Lo scopo del lavoro consiste nell'individuare le principali caratteristiche della moderna geografia linguistica (e della relativa area linguistica). Il raggiungimento di questo obiettivo implica la risoluzione di quanto segue compiti :
1) studio della letteratura scientifica su questo argomento;
2) considerazione dei concetti base della linguisticogeografia e della linguistica areale;
3) analisi dell'evoluzione della geografia linguistica come branca della linguistica;
4) individuazione di metodi specifici di linguisticogeografia e linguistica d'area.
In questo lavoro abbiamo utilizzato metodi analisi e sintesi, comparazione, ecc.
La geografia linguistica è stata studiata da scienziati come V.V. Vinogradov. Girutsky A.A. Zhuravlev V.K. Levitsky Yu.A., Boronnikova N.V. e così via.
Il lavoro del corso è composto da un'introduzione, due capitoli e una conclusione.
Il primo capitolo esamina la formazione della geografia linguistica. Il secondo capitolo è dedicato alla linguistica areale.
I. Capitolo. La formazione della geografia linguistica
1.1. Storia della nascita e dello sviluppo della geografia linguistica in Europa. Concetti di base di questa scienza
La geografia linguistica ha avuto origine negli anni 70-80. 19esimo secolo, quando furono scoperti fatti di discrepanza tra i confini dei singoli fenomeni linguistici. A questo proposito è nata l'idea dell'assenza di confini dialettali, della natura mista dei dialetti, e da qui l'idea che i dialetti non esistono affatto (P. Meyer, G. Paris). Questa idea suscitò obiezioni (G.I. Ascoli); la controversia poteva essere risolta solo attraverso una mappatura sistematica dei fenomeni linguistici. Nel 1876, in Germania, G. Wenner iniziò a raccogliere materiale per compilare un atlante linguistico della lingua tedesca; il lavoro fu continuato da F. Wrede, e nel 1926 furono pubblicate alcune mappe. In Francia, J. Gilleron ed E. Edmond realizzarono l'“Atlante linguistico della Francia”, che ebbe una grande influenza sullo sviluppo della geografia linguistica romanica ed europea, seguito da atlanti linguistici apparsi in Italia, Spagna, Svizzera, Romania; Si comincia a pubblicare gli atlanti delle singole province e regioni (ad esempio l'atlante delle città del Nord Italia).
Nel periodo di massimo splendore del neogrammatismo, G. Schuchardt si espresse contro l'interpretazione neogrammaticale delle leggi sane nell'articolo "Sulle leggi fonetiche (contro i neogrammatici)" (1885). Il suo articolo suscitò un acceso dibattito, al termine del quale i neogrammatici furono costretti a introdurre restrizioni al funzionamento delle leggi fonetiche. Schuchardt negò la natura assoluta dell'azione delle leggi fonetiche, sostenendo che vi fossero "cambiamenti fonetici sporadici". "Se fossi costretto ad ammettere", scrisse, "il concetto di" immutabilità ", lo applicherei piuttosto al fatto dell'esistenza di cambiamenti fonetici sporadici che alle leggi fonetiche, poiché ogni cambiamento fonetico a un certo punto è sporadico. . E se a tutti i costi è necessario caratterizzare questi punti di vista in contrasto tra loro, allora è opportuno parlare sulle leggi assolute e relative" (39, 308, Parte I).
Schuchardt si oppose anche alla possibilità di dividere la storia di una lingua in periodi cronologici chiaramente delimitati e negò l'esistenza di confini tra i singoli dialetti e le singole lingue. A suo avviso, "i dialetti locali, i sottodialetti, i dialetti e le lingue sono concetti assolutamente convenzionali", poiché "non esiste un'unica lingua esente da incroci ed elementi estranei". Egli vedeva la ragione principale dei cambiamenti linguistici nei continui incroci linguistici e nelle mescolanze di lingue. In accordo con questa tesi, Schuchardt avanzò, invece di una classificazione genealogica delle lingue, la teoria dell '"allineamento geografico", cioè la transizione continua di una lingua all'altra in base alla loro posizione geografica, rilevando la continuità della lingua nel complesso. Schuchardt, come i neogrammatici, considerava la lingua il prodotto di un individuo parlante, sottolineando che lo status sociale, le condizioni di vita di un individuo, il suo carattere, la cultura e l'età hanno un impatto diretto sulla lingua e formano uno stile individuale. Vede la parentela “elementare” delle lingue nella natura mentale comune delle persone.
Schuchardt prestò notevole attenzione alle questioni etimologiche, semasiologiche e ad altre questioni particolari della linguistica. Allo stesso tempo, ha osservato che i linguisti “devono imparare a trovare il generale nel particolare e, per questo motivo, la corretta comprensione di alcuni dei fatti più importanti che svolgono un ruolo decisivo nella scienza linguistica è molto più importante della comprensione di qualsiasi forma particolare. del fenomeno” (39, 310, parte 1). A suo avviso, «ogni linguistica particolare passa nel generale, deve esserne parte integrante, e quanto più la linguistica generale si eleva scientificamente, tanto più decisamente rifiuterà tutto ciò che è casuale ed empirico» (39, 312, parte I). Nell'analisi più attenta delle questioni particolari, la linguistica è obbligata a non perdere di vista il generale, il più generale. Queste disposizioni erano dirette contro l'empirismo dei neogrammatici.
Nello stesso periodo, in Germania, Georg Wenker (1852-1911), in Francia, Jules Gillieron (1854-1926), basandosi sull'“allineamento geografico” di Schuchardt e sulla “teoria delle onde” di J. Schmidt, crearono la geografia linguistica, origine della che furono Baudouin de Courtenay e G. Ascoli. Nel 1876 Wenker inviò un questionario agli insegnanti, al quale dieci anni dopo ricevette 40mila risposte. Come risultato dell’elaborazione di questi questionari e del lavoro del successore di Wenker, Ferdinand Wrede (1863-1934) nel 1926-1932. È stato pubblicato un atlante dialettologico tedesco in sei volumi. Era dedicato principalmente alla fonetica. La preparazione di un atlante dialettologico della Francia da parte di J. Gilleron in collaborazione con Edmond Edmond (1848-1926) iniziò più tardi di Venker, ma la sua edizione in 12 volumi fu pubblicata molto prima - nel 1902-1910. Si occupava principalmente di questioni di vocabolario. A differenza del metodo del questionario di Venker, l'atlante dialettologico francese è stato preparato utilizzando un metodo diretto: registrando accuratamente nella trascrizione fonetica le risposte locali a 639 voci del questionario.
La linguisticogeografia mostrò per la prima volta la complessità della lingua nelle relazioni territoriali e sociali. La tesi della "variazione geografica" della lingua di Schuchardt divenne ovvia: le matrici dialettali si rivelarono non continue, ma con diverse aree di distribuzione dei singoli fenomeni del discorso: parole, forme e suoni, le cosiddette isoglosse. Per la prima volta è stato possibile associare i confini delle isoglosse a ragioni di carattere culturale e storico. Anche la posizione di Schuchardt secondo cui la lingua è un continuum, una continuità, divenne ovvia con l'avvento della geografia linguistica. È stata confermata anche la posizione di Schuchardt secondo cui non esistono lingue non mescolate o discorsi non mescolati: i dialetti interagiscono costantemente sia tra loro che con la lingua scritta.
Schuchardt riteneva che la ragione principale dello sviluppo del linguaggio fosse la mescolanza delle lingue: "Tra tutti i problemi con cui si confronta attualmente la linguistica, forse nessuno è così importante come il problema della mescolanza linguistica". “Non esiste una sola lingua che sia esente da incroci ed elementi estranei”. È la mescolanza delle lingue che porta al loro cambiamento. Inoltre, le ragioni di questo processo sono sempre di natura sociale e non fisiologica. Il concetto di mescolanza delle lingue ha attirato l'attenzione sul fenomeno dei contatti linguistici, sulla ricerca nel campo del bilinguismo, della dialettologia e della geografia linguistica.
Sviluppando la “teoria delle onde” di Schmidt, Schuchardt propone l'idea di “continuità linguistica”, che porta alla negazione dell'esistenza di confini rigidi tra dialetti e lingue. “I dialetti e le lingue locali sono concetti assolutamente convenzionali”, “designazioni collettive geografiche”. Così, invece della classificazione genealogica, viene proposta una teoria della continuità geografica, cioè dell’“allineamento geografico”. continui passaggi da una lingua all’altra. Di conseguenza, nasce l'idea della parentela di tutte le lingue del mondo: “Riconosco che tutte le lingue del mondo sono imparentate, ma non sono imparentate in virtù dei loro antenati, ma solo perché questa parentela si è formata attraverso la partecipazione immediata, molto ampia, di mescolanza e assimilazione”. A questo proposito, Schuchardt richiede lo studio comparativo di lingue non imparentate, vale a dire alla ricerca tipologica.
Come notato da T.A. Amirov, “nella storia della linguistica, Schuchardt occupa un posto speciale come critico del vecchio e araldo del nuovo. Le sue opere, scritte tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, riflettevano, come in uno specchio, lo stato della scienza del linguaggio contemporanea. Le opere di Schuchardt indicano l’emergere di un nuovo approccio al linguaggio e lo sviluppo di nuovi metodi per la sua descrizione”.
Lo sviluppo della geografia linguistica è associato alla distinzione dei dialetti e alla creazione di atlanti dialettologici. La geografia linguistica si occupa quindi dello studio della distribuzione territoriale dei fenomeni linguistici.
Dal corso di geografia scolastica si conoscono concetti come “isoterma” (una linea che collega aree con la stessa temperatura), “isobare” (aree con la stessa pressione), ecc. Per analogia è nato il concetto di “isogloss”, cioè una linea che collega le aree sulla mappa in cui si osserva l'uno o l'altro fenomeno linguistico, ad esempio la stessa pronuncia di un suono o lo stesso nome di un oggetto (fenomeno). Lo studio della natura della distribuzione delle isoglosse ha mostrato che la loro distribuzione nel territorio occupato dalla lingua forma un intreccio complesso, mentre le isoglosse di diversi fenomeni linguistici caratteristici di un dato dialetto, di regola, non coincidono. Passando l'uno vicino all'altro si formano le isoglosse grappoli, tra i quali si distinguono territori caratterizzati da unità in relazione al fenomeno linguistico oggetto di studio. Sono proprio questi fasci di isoglosse che formano i dialetti territoriali.
Il concetto principale della geografia linguistica è “area linguistica”, cioè confini di distribuzione dei singoli fenomeni linguistici. In questo caso si distinguono tre zone principali: centrale, marginale (laterale) e di transizione, i cui rapporti tra loro sono così caratterizzati: nella più isolata delle due aree si conserva la fase precedente; lo stadio attestato nelle aree laterali è generalmente più precoce, purché l'area centrale non sia più isolata; la maggiore delle due aree conserva lo stadio precedente, purché l'area minore non sia più isolata e non sia costituita da aree laterali; se una delle due fasi risulta essere obsoleta o pronta
scompaiono, di solito scompare per prima la fase più antica.
Poiché la diffusione dei fenomeni linguistici avviene non solo nello spazio, ma anche nel tempo, possiamo giudicare la relativa antichità di questi fenomeni.
L'impulso per l'uso diffuso dei metodi di mappatura linguistica fu in gran parte il vivace dibattito scientifico di quel tempo sull'esistenza dei confini tra i singoli dialetti. Il materiale dialettale accumulato ha mostrato che i confini delle singole caratteristiche dialettali spesso non coincidono tra loro. Ciò ha portato all'idea errata che i dialetti non esistano come unità territoriali indipendenti. Il dibattito su questo tema potrebbe essere risolto solo attraverso una mappatura sistematica di molti fenomeni linguistici individuali. Questa situazione alla fine portò all'idea di creare atlanti dialettologici come una raccolta di mappe linguistiche, ciascuna delle quali è dedicata a un fenomeno linguistico separato. Questa idea è associata alla separazione della geografia linguistica in una disciplina indipendente, il cui oggetto è stabilire i confini della distribuzione territoriale dei fenomeni linguistici.
Tuttavia, la mappatura dei fatti linguistici non è fine a se stessa. La loro distribuzione geografica riflette i modelli di sviluppo del linguaggio ed è una fonte di dati sulla storia e sulle caratteristiche strutturali dei suoi dialetti territoriali. La distribuzione territoriale dei fatti linguistici riflette anche il destino degli stessi madrelingua, la storia dei popoli, le relazioni culturali, politiche e socioeconomiche della popolazione nel passato.
I compiti della geografia linguistica come scienza vanno quindi ben oltre l’ambito della semplice cartografia, che fornisce ai ricercatori solo materiale sistematizzato e presentato visivamente sulle carte. Il lato sostanziale di questa scienza è uno studio completo delle informazioni linguistiche contenute nelle mappe linguistiche in connessione con i dati della storia della lingua e della storia delle persone.
Dalla fine del XIX secolo, in molti paesi del mondo iniziarono a essere creati atlanti dialettologici. Tra i primi vi fu l’“Atlante linguistico della Francia” (autori J. Gillieron e E. Edmond), che iniziò a essere pubblicato a Parigi nel 1903.
Con tutta la varietà di approcci alla mappatura del materiale negli atlanti dialettologici di diverse lingue, il lavoro su di essi si basa su alcuni principi generali. I principali sono i seguenti.
La raccolta del materiale linguistico viene effettuata secondo un programma appositamente sviluppato per l'atlante. Gli insediamenti rurali vengono tutti censiti o, più spesso, utilizzando una griglia più o meno fitta. La raccolta del materiale viene effettuata, di norma, da soggetti con particolare formazione linguistica (dagli studenti ai professori), attraverso l'osservazione diretta dei dialetti e la registrazione del materiale in un'unica trascrizione fonetica. A volte è consentito un metodo di questionario rivolto agli intellettuali rurali. Il materiale viene raccolto in un tempo relativamente breve, poiché si intende la sincronicità dei dati raccolti.
Ogni mappa dell'atlante si basa solitamente sul materiale raccolto su un argomento specifico del programma. Pertanto, la natura delle domande del programma determina in gran parte il contenuto delle carte. I programmi stessi e i metodi di mappatura negli atlanti dialettologici di diverse lingue possono variare in modo significativo.
Gli atlanti linguistici delle singole lingue (o atlanti dialettologici) rappresentano la struttura dei sistemi dialettali in un determinato momento e forniscono uno spaccato sincrono della lingua nella sua proiezione territoriale. Gli atlanti contengono materiale inestimabile per risolvere un'ampia varietà di problemi sia nella linguistica sincronica che, prima di tutto, storica. Pertanto, la creazione di un atlante dialettologico è sempre un potente impulso per l'ulteriore studio della lingua, determinando per molti anni il progresso della linguistica nazionale.
Oltre agli atlanti delle singole lingue nazionali, vengono creati anche atlanti di carattere più specializzato, ad esempio atlanti delle singole regioni della distribuzione di una lingua al di fuori del territorio principale della sua esistenza, atlanti dedicati a problemi ristretti: fonetico, lessicale con uno sviluppo dettagliato di una certa gamma di relazioni semantiche, atlanti della distribuzione di determinati modelli di formazione delle parole e così via.
In termini di copertura del materiale linguistico, gli atlanti linguistici possono andare oltre i dialetti di una lingua e presentare sulle loro mappe dati sulla geografia dei fenomeni linguistici sulla scala delle lingue correlate, ad esempio l'"Atlante linguistico slavo comune" o " Atlante delle lingue turche", nonché lingue non correlate, come l'" Atlante linguistico dell'Europa" o l'"Atlante linguistico dei Carpazi". Sono tutte opere grandiose che dimostrano la fruttuosa cooperazione internazionale nel campo della scienza. La loro importanza è inestimabile per lo sviluppo dei problemi dell'origine delle lingue, della storia dei contatti interlinguistici, nonché delle questioni di tipologia in relazione a lingue di vario grado di prossimità.
1.2. Sviluppo della geografia linguistica in Russia. Mappatura dei fenomeni linguistici
In Russia, a metà del XIX secolo. Si è realizzata la necessità di uno studio geografico dei dati dialettali. I. I. Sreznevsky nelle sue "Note sul materiale per la geografia della lingua" (1851) parlò del "primo bisogno urgente della scienza: la compilazione di una mappa linguistica". Anche AI Sobolevskij era un sostenitore di questo metodo, insistendo sulla necessità di studiare la distribuzione territoriale dei singoli fenomeni linguistici.
I primi passi pratici in quest'area sono associati al nome di A. A. Shakhmatov, sotto la cui guida è stato sviluppato il "Programma per la raccolta delle caratteristiche dei dialetti popolari" (in 2 parti - pubblicato nel 1895, 1896). Rifletteva tutte le caratteristiche dialettali della lingua russa allora conosciute nel campo della fonetica, della morfologia, della sintassi e del vocabolario. La pubblicazione del materiale raccolto nell'ambito di questo programma ha dato un impulso significativo allo studio delle differenze territoriali nella lingua russa. "Dizionario del discorso dialettale popolare russo in Siberia nel XVII - prima metà del XVIII secolo", compilato da L.G. Panin principalmente sulla base di monumenti di scrittura commerciale. Tra le fonti del "Dizionario fraseologico dei dialetti russi della Siberia", edito da A. I. Fedorov, ci sono dati provenienti da dialetti moderni e registrazioni dialettologiche del discorso siberiano fatte da vari ricercatori nel XIX e all'inizio del XX secolo. I dialetti di un gruppo confessionale speciale si riflettono nel "Dizionario dei dialetti dei vecchi credenti (Semeisk) della Transbaikalia" edito da T. B. Yumsunova.
I dizionari inversi servono come un buon strumento per la formazione delle parole, l'analisi del vocabolario dialettale dal punto di vista dell'appartenenza a diverse classi morfologiche, ad esempio "L'esperienza di un dizionario dialettale inverso" a cura di M.P. Yantsenetskaya, "Indice di inversione del dizionario dei dialetti popolari russi" compilato da F.P. Sorokoletov e R.V. Odekov, a cura di F. Gledni.
Il lavoro mirato direttamente alla mappatura iniziò nel 1903, quando fu creata presso l'Accademia delle Scienze, sotto la presidenza di E.F. Korsh, la Commissione dialettologica di Mosca (MDC), che esisteva fino alla metà degli anni '30. I suoi membri in tempi diversi includevano scienziati come N.N. Durnovo, D.N. Ushakov, E.F. Korsh, I.G. Golanov, R.I. Avanesov. La commissione ha sviluppato e diffuso un “Programma per la raccolta delle informazioni necessarie per compilare una mappa dialettologica della lingua russa”. Costruito sugli stessi principi di prima, questo programma era meno complicato e prevedeva una migliore organizzazione del materiale. La fonetica era particolarmente ben sviluppata in esso. Sulla base del materiale raccolto nell'ambito di questo programma (principalmente attraverso questionari), i membri dell'IDC N.N. Durnovo, N.N. Sokolov e D.N. Ushakov prepararono e nel 1915 pubblicarono una “Mappa dialettologica della lingua russa in Europa con un'appendice di un saggio sulla dialettologia russa ". Questo lavoro è diventato una pietra miliare nella storia della geografia linguistica russa. La mappa IDC per la prima volta delineava i territori di distribuzione di tre lingue slave orientali: russo (“grande russo”), ucraino (“piccolo russo”) e bielorusso e mostrava la loro divisione dialettale interna. Per la lingua russa, furono assegnati i territori di due dialetti principali: settentrionale e meridionale, e tra loro fu definita una striscia di dialetti della Russia centrale.
Tuttavia, nonostante tutto il significato positivo di “Esperienza”, la mappa MDK, costruita tenendo conto della distribuzione solo di poche caratteristiche, per lo più fonetiche, soffriva di schematismo. La convenzione associata di identificare le divisioni dialettali su di esso fin dall'inizio ha suscitato l'atteggiamento critico di A. I. Sobolevskij e di un certo numero di altri scienziati, che hanno ritenuto necessario chiarirne i dati sulla base della mappatura di molti fenomeni linguistici individuali. Si è così affermata l'idea della necessità di creare un atlante dialettologico della lingua russa.
I lavori preparatori per la creazione di un atlante dialettologico della lingua russa (DARY) iniziarono nella seconda metà degli anni '30. presso la filiale di Leningrado dell'Accademia delle scienze dell'URSS. Qui è stato compilato il “Questionario per la creazione di un atlante dialettologico della lingua russa” (1936, autori B.A. Larin, F.P. Filin, N.P. Grinkova), ed è iniziata un'indagine sui dialetti del Nord-Ovest e una mappatura sperimentale. I lavori interrotti dalla guerra ripresero subito dopo la sua fine. Il centro per la ricerca dialettologica si trasferì a Mosca, dove R. I. Avanesov divenne il capo dei lavori per la creazione dell'atlante. Ha guidato e organizzato un lavoro su vasta scala per raccogliere materiale per l'atlante sul vasto territorio del più antico insediamento russo (il Centro della Russia europea). In questo lavoro negli anni Quaranta - Sessanta. Hanno preso parte lavoratori delle facoltà filologiche di molte università del paese. Il materiale è stato raccolto da più di 5.000 insediamenti secondo un nuovo programma, notevolmente ampliato e rivisto ("Programma per la raccolta di informazioni per la compilazione di un atlante dialettologico della lingua russa." Yaroslavl, 1945), che ha sostituito il "Questionario" prebellico.
La mappatura del materiale raccolto è stata inizialmente effettuata all'interno di cinque regioni separate della distribuzione della lingua russa. Questa fase di lavoro fu completata nel 1970. Degli atlanti regionali, ne fu pubblicato solo uno: "Atlante dei dialetti popolari russi delle regioni centrali a est di Mosca" (M., 1957).
In questo atlante, la teoria della geografia linguistica sviluppata da R.I. Avanesov è stata applicata per la prima volta in pratica a materiale dialettale specifico.
Lo sviluppo della teoria è proceduto parallelamente all'accumulo di esperienza nella creazione di mappe linguistiche dell'atlante russo. Nel 1962 fu pubblicato il libro "Issues of the Theory of Linguistic Geography", che delineava i principi della mappatura linguistica di tutti i livelli della lingua nella comprensione della Scuola di geografia linguistica di Mosca (i suoi autori: R. I. Avanesov, S. V. Bromley, L. N. Bulatova , L.P. Zhukovskaya, I.B. Kuzmina, E.V. Nemchenko, V.G. Orlova). Ci sono voluti altri dieci anni (1971 - 1980) per riassumere cinque atlanti regionali nel consolidato "Atlante dialettologico della lingua russa: Centro per la parte europea dell'URSS" (DARY), che è stato pubblicato in 3 numeri: I - "Fonetica ”, II - “Morfologia” , III - “Sintassi. Vocabolario".
Il lavoro su DARY è iniziato in un'epoca in cui nei lavori sulla geografia linguistica delle lingue europee prevaleva ancora il metodo empirico e atomico. Oggetto della mappatura erano solitamente le singole parole, che venivano registrate su una mappa (spesso semplicemente scritte su di essa) riflettendo tutte le caratteristiche della loro pronuncia, senza tentativi di differenziare fenomeni qualitativamente diversi riflessi nella variazione di alcuni elementi della parola.
Fin dai primi passi, il lavoro del team di dialettologi di Mosca ha iniziato ad adottare un approccio sistematico alla lingua e, prima di tutto, ciò si è riflesso nella scelta dell'oggetto della mappatura. La teoria della geografia linguistica, sviluppata all'interno della scuola di Mosca, si basa sulla teoria delle differenze dialettali di R. I. Avanesov, basata sulla comprensione della lingua dialettale russa come un sistema complesso, che comprende caratteristiche generali e particolari, caratteristiche di unità e differenze. Quei collegamenti nel sistema linguistico generale in cui si riscontrano differenze nei dialetti costituiscono la corrispondenza interdialettale. È la corrispondenza interdialettale l'oggetto della geografia linguistica, cioè tema della mappatura su mappe linguistiche.
I membri delle corrispondenze interdialettali vengono contrapposti tra loro sulla mappa non in modo unilineare, ma tenendo conto delle caratteristiche in base alle quali sono combinati o differenziati. "Sulle mappe dell'atlante dialettologico", scrive R.I. Avanesov, "si tiene sistematicamente conto del fatto che ogni singolo fatto di solito rappresenta, per così dire, una linea di intersezione di fenomeni dialettali generali e particolari di diversa qualità - fonetici, morfologici, sintattico, lessicale. Pertanto, il compito di molte delle mappe linguistiche più complesse è<...>dipanare la matassa di fenomeni sulla linea di intersezione di ciascuno di questi fatti dialettali per evidenziare i singoli fenomeni dialettali incrociati in questo particolare fatto nelle loro connessioni strutturali”.
La conseguenza pratica di questa visione dell’oggetto della mappatura è stata la volontà di costruire mappe linguistiche in modo che il loro “linguaggio”, cioè il sistema di simboli utilizzato su di essi rifletteva nel modo più completo la struttura delle corrispondenze interdialettali mappate e la natura della relazione tra i suoi membri. Pertanto, nei metodi cartografici, un posto non meno importante è occupato dallo sviluppo di un tale sistema di segni utilizzati sulla mappa, dove ciascun segno cartografico non designa semplicemente uno dei membri di una determinata corrispondenza interdialettale, ma mostra le connessioni e opposizioni in cui si trova questo membro rispetto a tutti gli altri membri della corrispondenza, contrassegnati con altri segni.
Durante la mappatura viene fatta una distinzione coerente tra diversi livelli di linguaggio. Ogni carta è dedicata ad un fenomeno di un livello. Allo stesso tempo, ad ogni livello successivo e superiore, quelle differenze linguistiche associate a variazioni nelle unità di livello inferiore non vengono prese in considerazione (combinate). Dimostriamo questa posizione utilizzando la relazione tra i fenomeni a livello fonetico e grammaticale. Ad esempio, sotto forma di creatività. gioco di parole. compresi i sostantivi (femminile) R. 1 ° Classe i finali possono assomigliare a questo: bab[oh], bab[sh], bab[esch, bab[uy]. Le prime tre opzioni vengono combinate durante la mappatura, poiché la loro differenza riguarda la fonetica (vocalismo non accentato). A livello morfologico tutte, in quanto forme con il fonema /o/, si oppongono alla variante donna[ahi], poiché [y] in nessuno dei sistemi dialettali è una variante regolare non accentata del fonema /o/, ma rappresenta un fonema indipendente /y/.
Le relazioni tra unità di altri livelli sono costruite in modo simile.
Nella teoria della linguisticogeografia è importante determinare la gamma di fatti linguistici che devono essere presi in considerazione quando si mappa una particolare corrispondenza interdialettale. Questo problema viene risolto anche in relazione alla loro posizione nel sistema linguistico. La fonetica è, di regola, caratterizzata da fenomeni regolari, limitati solo dalla posizione fonetica. Sono presentati in una gamma illimitata di parole. Pertanto, durante la mappatura, ad esempio, i suoni sono a posto V nel mezzo di una parola prima delle consonanti sorde, vengono prese in considerazione tutte le forme di parole contenenti questo suono etimologico: erba, panca, avena, mestolo eccetera.
In morfologia i fenomeni di solito coprono anche tutte le parole di una data classe grammaticale. Ad esempio, [t] duro o [t "] morbido alla fine della terza riga è rappresentato allo stesso modo in tutti i verbi. Pertanto, quando si mappa questa caratteristica, vengono presi in considerazione tutti i verbi registrati in questa forma: cammina, guida, si siede, vi dit, corri, guarda eccetera.
La classe di parole all'interno della quale è rappresentata l'una o l'altra corrispondenza interdialettale in una lingua può comprendere un numero diverso di unità, da un insieme indefinito (come mostrato sopra) a più parole e persino a una parola. Questa posizione fonetica può essere rappresentata nella lingua da una sola parola. Ad esempio, la combinazione /zh"/ alla fine di una parola ricorre solo nella parola piovere. In morfologia, questa situazione è solitamente associata a un tipo isolato di inflessione, ad esempio la declinazione di una parola sentiero. A seconda della natura del fenomeno linguistico, la mappa viene costruita tenendo conto della gamma di fatti (parole, frasi, ecc.) con cui questo fenomeno viene rappresentato nella lingua.
Sulla base delle mappe dell'Atlante vengono risolti molti importanti problemi legati allo studio dello stato sincronico della lingua, nonché la storia della sua struttura e la formazione dei dialetti stessi come comunità territoriali di vario grado di prossimità.
Ma per risolvere questi problemi è necessaria la capacità di leggere una mappa, comprenderne il “linguaggio” e analizzarne il contenuto.
Il concetto principale della geografia linguistica è l'isoglossa. Un'isoglossa è una linea su una mappa che delimita l'area di distribuzione di un particolare fenomeno linguistico o membro di una corrispondenza interdialettale. Se i membri della corrispondenza interdialettale si escludono completamente a vicenda in un territorio, allora l'isoglossa è allo stesso tempo il confine della distribuzione dei diversi membri della corrispondenza interdialettale. In pratica, questa situazione si verifica raramente nei dialetti russi. Avvicinandosi a tale delimitazione territoriale dei membri della corrispondenza interdialettale isoglosse [g] e [y], okanya e akanya, forme creative. p.m. compresi i sostantivi -ami E -Sono. Solitamente le isoglosse dei diversi membri della corrispondenza interdialettale si sovrappongono almeno in parte del territorio. In questo caso si formano tra loro zone di coesistenza di diverse dimensioni e configurazioni.
Strettamente correlato al concetto di isogloss è il concetto di area linguistica, ovvero il territorio delimitato dall'isogloss in cui è diffuso un dato fenomeno linguistico. L'insieme delle aree tipiche presentate sulle carte dell'atlante dialettologico è spesso chiamato paesaggio linguistico di una determinata lingua.
La configurazione delle aree linguistiche è oggetto di una branca speciale della linguistica, la linguistica areale, che si occupa di individuare la tipologia delle aree, collegando la loro configurazione con la natura del fenomeno linguistico stesso. Ad esempio, fenomeni rappresentati da ampi tratti e situati al centro del paesaggio linguistico - aree centrali - sono solitamente associati a innovazioni, mentre fenomeni situati alla periferia - aree marginali, rappresentati da aree rotte ("pizzi"), sono associati a arcaismi. Questa direzione ha origine dal lavoro della scuola dello scienziato italiano M. Bartoli. Introdusse il concetto di norma areale come una sorta di rapporto tra il grado di arcaicità o di novità di un fatto linguistico e la natura dell'area.
Gli isoglossi di diversi livelli linguistici hanno le loro caratteristiche caratteristiche. Così, ad esempio, le isoglosse dei fenomeni fonetici tipici, così come quelli morfologici, se rappresentano differenze regolari, di solito evidenziano matrici di territori più olistiche e definite, mentre le isoglosse lessicali sono più spesso associate all'identificazione di molte piccole aree. Ecco perché l'identificazione delle grandi unità di divisione dialettale si basa principalmente su isoglosse di fenomeni fonetici e morfologici tipici.
Le isoglosse dei diversi fenomeni dialettali attraversano il territorio della lingua in varie direzioni. Tuttavia, in alcune parti di esso, le isoglosse che vanno in una direzione si condensano, formando i cosiddetti fasci di isoglosse. Un mucchio di isoglosse segnala che qui c'è un confine dialettale.
Quanti più fenomeni sono compresi in un fascio di isoglosse, tanto più significative nella loro gerarchia sono le unità di divisione dialettale che esso delimita. Grandi gruppi dialettali distinti da tali fasci sono a loro volta intersecati da certi fasci di isoglosse, evidenziando in essi unità più piccole di divisione dialettale - gruppi di dialetti.
Anche i fenomeni linguistici più vicini in natura mostrano qualche, seppure molto lieve, discrepanza tra i loro confini. Tuttavia, la presenza tra le isoglosse estreme comprese nel fascio di una fascia più o meno ampia di dialetti di transizione (o, nella terminologia della linguistica areale, di una “zona di vibrazione”) non significa che non esistano dialetti, poiché nel Nei territori su entrambi i lati del fascio isoglosso ci sono dialetti che possono dimostrare una significativa unità del loro sistema a tutti i livelli del sistema.
Ogni lingua è caratterizzata solo dalle sue caratteristiche intrinseche del panorama linguistico. Nel panorama linguistico russo, il fascio di isoglosse più significativo, caratterizzato da una distanza molto ampia tra le isoglosse estreme, distingue i dialetti meridionali e settentrionali. L'ampia fascia formata dalle isoglosse di questo fascio comprende essenzialmente tutti i dialetti della Russia centrale con una diversa combinazione di caratteristiche di entrambi i dialetti nelle loro diverse suddivisioni.
Le possibilità dello studio sia sincrono che storico dei dialetti utilizzando i metodi della geografia linguistica sono strettamente legate ai principi di costruzione delle mappe linguistiche stesse. L'atlante dialettologico russo, con il suo approccio sistematico all'identificazione dell'oggetto della mappatura, la divisione in segni della mappa delle caratteristiche con cui viene effettuato il contrasto dei fatti linguistici nei dialetti, apre ampie opportunità per tale studio. Ciò che viene presentato ai ricercatori non è materia prima ancora da comprendere e classificare, ma singoli mattoni o interi blocchi (più o meno grandi) che costituiscono gli elementi strutturalmente distinti dei moderni sistemi dialettali.
Ciò consente di estrarre direttamente informazioni dalle mappe (confrontandole tra loro) sui tratti caratteristici della struttura dei dialetti. Ad esempio, si possono vedere diversi gradi di sviluppo della categoria durezza-morbidezza delle consonanti in diversi tipi di dialetti (il suo maggiore sviluppo in quelli centrali), notare differenze nella struttura fonetica delle inflessioni (conservazione delle vocali finali in essi in la zona dialettale nord-orientale, cfr forme simili saluta, vai, non preoccuparti ecc.), lo sviluppo di nuove formazioni nell'area dello stress (nei dialetti della zona occidentale) e molti altri fenomeni prima o del tutto sconosciuti o privi di esatte coordinate territoriali.
Il ruolo dei dati linguistico-geografici per lo studio storico della lingua è ancora più significativo.
Sebbene le carte dell'Atlante nel loro insieme forniscano un'istantanea sincrona della struttura della lingua, e la carta della divisione dialettale creata sulla loro base rappresenti un'immagine dei dialetti nella forma in cui si è conservata oggi, entrambe queste varietà della Il metodo geografico di rappresentazione dei dati linguistici può essere interpretato con successo retrospettivamente per ripristinare la storia della struttura fonetica e grammaticale della lingua e la storia della formazione dei suoi dialetti.
In entrambi i casi, l’attenzione principale dovrebbe essere rivolta all’interpretazione delle isoglosse e ai confini dialettali stabiliti sulla base di esse, dal momento che “l’isogloss<...>è il risultato dell’intero percorso di sviluppo storico che una data lingua ha percorso.” Non è un caso che sia stato a lungo notato che i confini dialettali, definiti da fasci di isoglosse, spesso sono correlati in un modo o nell'altro con i confini di ex associazioni statali, feudali e talvolta anche tribali.
L'interpretazione delle carte ai fini dello studio dei fenomeni linguistici nel loro sviluppo implica quindi non solo il ricorso a monumenti scritti che riflettono la lingua dei territori corrispondenti, ma anche il coinvolgimento di dati specifici provenienti dalla storia dei popoli, dalla geografia storica, dall'etnografia e dall'archeologia. La natura del paesaggio linguistico non può essere l'unico (o anche il principale) criterio per valutare la relativa antichità delle varianti linguistiche, poiché la formazione di elementi di questo paesaggio può avvenire non solo come risultato di diversi processi di sviluppo interno della lingua , ma anche in condizioni storiche diverse.
Mostrando il percorso specifico di sviluppo di un fenomeno linguistico, la cronologia relativa della comparsa delle sue diverse varianti, sulla base dei dati delle mappe linguistiche, si può fare solo analizzando il rapporto tra le aree di queste varianti, confrontandole con le aree di altri fenomeni ad essi strutturalmente correlati, e tenendo conto anche dei dati dei monumenti scritti, se disponibili. Questi ultimi possono essere pietre miliari nel percorso per stabilire la cronologia assoluta del verificarsi di determinati fenomeni o processi. Nella geografia linguistica russa esistono già molti esperimenti riusciti di tale interpretazione, basata sulla combinazione di isoglosse di fenomeni correlati internamente.
1.3. Divisione dialettale della lingua russa
La lingua nazionale russa è un complesso sistema gerarchico che comprende i dialetti e la lingua letteraria nelle sue forme scritta e orale. L'unità di questo sistema è determinata dalla presenza di una base comune in tutte le forme della sua esistenza e dalla natura delle differenze dialettali nei dialetti russi, che, essendo membri corrispondenti degli stessi collegamenti nel sistema, sono intercambiabili e quindi comprensibili a tutti parlanti nativi, qualunque sia il dialetto che parlano. Inoltre, l'effetto delle principali tendenze nello sviluppo della struttura fonetica della lingua russa si estende a tutti i suoi dialetti, anche se in misura diversa. Ciò è facilitato anche dalla pronuncia letteraria, le cui radici sono anche legate alla formazione e allo sviluppo di uno dei dialetti russi originari, il cui centro moderno è Mosca.
Per gli stessi scopi, il grado di corrispondenza tra la lingua dialettale e la mappa della divisione dialettale può essere diverso, il che dipende da ragioni oggettive e soggettive, vale a dire: dalla natura delle differenze dialettali nella lingua stessa e dal livello di sviluppo della lingua la scienza che li riguarda, in altre parole, sul materiale scientifico di partenza, alla base della mappa, e sui principi della sua elaborazione e generalizzazione.
Attualmente esistono due mappe della divisione dialettale della lingua russa con un intervallo di tempo di 50 anni. È anche possibile creare altre mappe sullo stesso materiale, basate su altri principi di utilizzo e trattamento del materiale di partenza, o con altri scopi: tipologici, genetici, ecc.
La creazione nel 1914 della prima mappa - "L'esperienza di una mappa dialettologica della lingua russa in Europa", compilata da N.N. Durnovo, N.N. Sokolov e D.N. Ushakov, divenne un evento scientifico eccezionale del suo tempo e ebbe non solo valore pratico, ma ha anche un importante significato teorico. Questa mappa affermava la presenza nella lingua moderna dei dialetti come varietà locali della lingua nazionale. Pertanto, i creatori della mappa confutavano l'opinione diffusa a quel tempo secondo cui solo le isoglosse dei singoli fenomeni dialettali sono reali nella lingua e non esistono territori integrali di comunità linguistiche.
La mappa di “Esperienza...” comprendeva l’intero territorio della lingua russa in Europa, compresi i territori di insediamento tardivo, dove la popolazione russa si è intervallata con quella di lingua straniera, e i territori del nord, dove i russi si sono stabiliti principalmente lungo il fiumi, senza occupare l'intero territorio. Inoltre, le lingue ucraina e bielorussa, secondo le opinioni dell'epoca, erano presentate sulla mappa anche sotto forma di avverbi della lingua russa.
L'attenzione principale è stata prestata alle più grandi unità linguistico-territoriali: gli avverbi. Gli avverbi della lingua russa - il grande russo settentrionale (s-v-r) e il grande russo meridionale (yu-v-r) - erano distinti da isoglosse di quattro varianti di fenomeni opposte a coppie, una delle quali era dialettale e l'altra coincideva con la lingua letteraria russa lingua. Questi fenomeni (rispettivamente per gli avverbi s-v-r - yu-v-r) sono i seguenti: okanye - akanye, [g] - [y], D/ - /t "/ alla fine della 3a unità e nelle parti plurali dei verbi, /a / - /e/ alla fine del genere e dei pronomi vn.: io, tu, te stesso - io, tu, te stesso. Ogni avverbio era caratterizzato dal proprio complesso di questi quattro membri. Allo stesso tempo, l'avverbio yu-v-r si distingueva per una combinazione di isoglosse di membri dialettali: la presenza di [u], /t"/, /e/ (Me), e l'avverbio s-v-r - in un solo modo - okanem, poiché i corrispondenti membri dei restanti fenomeni coincidevano con la lingua letteraria.
Questa divisione dialettale univa illegalmente in un unico dialetto i dialetti locali, caratterizzati da vocalizzazioni strutturalmente diverse. Inoltre, una tale divisione dei dialetti russi separava i dialetti Akka Mosca dalla regione Akaya Vladimir-Volga, che in passato aveva la stessa base, appartenente al dialetto Rostov-Suzdal.
Questa tipologia si basa su un metodo statistico per valutare la relazione di tutte le caratteristiche dialettali rilevate in DARY. Allo stesso tempo, il significato linguistico degli avverbi veniva oscurato. Cominciarono a essere considerati i dati originali della lingua, mentre i dialetti stessi - formazioni storiche del piano linguistico - sorsero come risultato dell'interazione dei dialetti nelle condizioni della formazione dello stato russo e della lingua russa, guidata da il Grande Principato di Mosca con la predominanza del dialetto Rostov-Suzdal.
I confini degli avverbi in “Esperienza...” sono definiti e descritti in modo molto preciso, poiché sono disegnati lungo una linea: nell'avverbio s-v-r da okanya; nel sud-w-r avverbio secondo la fricativa [y]. Tra i dialetti s-v-r e yu-v-r c'erano i dialetti della Russia centrale dell'acacia, considerati "di transizione", con una base della Grande Russia settentrionale e uno strato della Grande Russia meridionale.
La mappa del 1914 mostra la natura lineare della divisione dialettale. Allo stesso tempo, l'intera complessità della lingua dialettale è espressa dalla separazione di due grandi unità linguistico-territoriali: i dialetti e i dialetti della Russia centrale di transizione tra loro. Gli avverbi, a loro volta, sono divisi in unità più piccole: gruppi di dialetti basati su una caratteristica, diversa per ciascuno degli avverbi. Questa divisione dialettale dei dialetti della lingua russa ha semplificato in modo significativo la relazione reale tra le associazioni dialettali territoriali e ha influenzato la comprensione della storia della loro formazione.
La nuova mappa della divisione dialettale copre i dialetti russi solo nel territorio dell'insediamento originario degli slavi orientali, dove si formarono originariamente i dialetti russi e la lingua nazionale russa. Questo territorio è rappresentato principalmente sulle mappe dell '"Atlante dialettologico della lingua russa". I materiali e le mappe di questo atlante sono stati la base e la fonte della mappa dialettologica della lingua russa nel 1964.
L'analisi delle mappe dell'“Atlante dialettale...” ha permesso di scoprire il complesso panorama linguistico-territoriale della lingua dialettale russa per il fatto che i corrispondenti membri interdialettali di ciascun fenomeno sono in esso mostrati separatamente, analiticamente secondo il loro livello. Ciò ha permesso di immaginare la natura della distribuzione dei fatti linguistici a più livelli e di correlare i loro territori tra loro. Si è scoperto che solo una minoranza di fenomeni dialettali hanno una distribuzione territoriale di tipo insulare, unica, individuale e sparsa. La maggior parte dei fenomeni dialettali hanno aree di distribuzione ripetitive (sebbene di solito non coincidano completamente), che si sovrappongono, si intersecano o si escludono reciprocamente, creando un complesso intreccio di fasci isoglossi.
Questo tipo areale di distribuzione territoriale dei fenomeni dialettali è servito come base per il raggruppamento dei dialetti della lingua russa. Allo stesso tempo, per creare una mappa della divisione dialettale, è stato applicato un principio differenziale di selezione del materiale: è stato preso solo materiale dialettale con distribuzione areale. Le associazioni linguistico-territoriali si distinguevano per la somma di tutti i fenomeni dialettali inerenti a ciascuna area. Allo stesso tempo si è tenuto conto delle loro caratteristiche linguistiche e della natura del fascio di isoglosse che evidenziano l'area. Di conseguenza, sono stati identificati tre tipi di associazioni linguistico-territoriali esistenti nella lingua dialettale russa; la loro gerarchia e posizione relativa ha determinato la natura della divisione dialettale.
La prima tipologia di associazione linguistico-territoriale è la più estesa in termini di copertura territoriale. Aree di questo tipo dividono l'intero territorio della lingua russa in due grandi parti: settentrionale e meridionale e formano i dialetti settentrionale e meridionale della lingua russa.
La seconda tipologia di aree linguistico-territoriali sono le zone dialettali. Loro, come gli avverbi, rappresentano vasti territori che uniscono i dialetti da una somma di caratteristiche comuni. Ci sono otto zone dialettali in totale.
Il terzo tipo di associazioni linguistico-territoriali sono i gruppi di dialetti. Rappresentano aree relativamente piccole, sempre comprese nei territori dei dialetti e delle zone dialettali e separate tra loro da fasci di isoglosse delle zone dialettali.
I tre tipi di associazioni linguistico-territoriali differiscono non solo per l'ampiezza delle loro aree, ma, soprattutto, per i loro rapporti gerarchici.
Sia gli avverbi che le zone dialettali si distinguono per la somma dei singoli tratti dialettali strutturalmente estranei tra loro, da
relativi a diversi livelli linguistici e unendo diversi dialetti nelle loro aree. Ma con la divisione dialettale, gli avverbi sono di maggiore importanza, poiché sono associazioni dialettali opposte a coppie che hanno gli stessi fenomeni corrispondenti nel loro complesso di caratteristiche.
Una caratteristica delle zone dialettali è la loro
correlazione tra loro attraverso un complesso di fenomeni. Ogni zona dialettale, pur coprendo geograficamente, è significativa
parti dei dialetti settentrionali o meridionali, si riferisce alla divisione del non
avverbi, ma l'intera lingua dialettale russa.
La zona dialettale centrale è assegnata secondo un principio speciale. Le caratteristiche della struttura sonora e grammaticale e del fondo lessicale caratteristici dei suoi dialetti, caratteristici della lingua letteraria, sono organicamente inerenti e primordiali e non vengono apprese dalla lingua letteraria. L'identificazione della zona dialettale centrale è di fondamentale importanza, perché in questo territorio ha avuto origine la lingua russa propriamente detta, distinta dalle altre lingue slave orientali. Le moderne differenze tra i dialetti sul territorio della zona centrale sono sorte in un secondo momento a seguito della ridistribuzione dei centri feudali sul territorio del Granducato di Mosca. Pertanto, nonostante le differenze visibili e sorprendenti tra i dialetti di Mosca e Vladimir (come Akanye e Okanye), questi dialetti hanno molto in comune nel loro suono e nella struttura grammaticale e insieme si oppongono sia ai dialetti Akaya del dialetto meridionale che ai dialetti okaya del il dialetto settentrionale.
I fenomeni inerenti ai dialetti della zona dialettale centrale, con i quali contrasta con tutte le altre zone dialettali della lingua russa, rappresentano nuove formazioni dell'antico dialetto di Rostov-Suzdal nel campo della struttura ritmico-dinamica della parola, del suono e struttura grammaticale. Questi includono: un sistema vocale a cinque fonemi e l'assenza dei fonemi /so/ e /b/, la presenza di [e] al posto di /b/, [o] al posto *e, b davanti alle consonanti dure, labiodentali /v/-/f/, distinguendo le affricate /ts/-/ch/; tipo di declinazione dei sostantivi secondo il modello della varietà solida, ecc.
Le zone dialettali hanno un valore ausiliario per la mappa di divisione dialettale, quindi non vengono mostrate sulla mappa principale. Loro, in combinazione con gli avverbi, caratterizzano la base dialettale di gruppi di dialetti, mostrando il grado di vicinanza reciproca. Ma il significato delle zone dialettali è importante per comprendere la storia dei singoli fenomeni linguistici e la storia della lingua russa nel suo insieme. La localizzazione di alcune caratteristiche linguistiche sul territorio delle singole zone indica che all'interno di questi territori, in determinate fasi storiche, erano in atto tendenze locali nello sviluppo linguistico. Confronta, ad esempio, la vicinanza dei confini della zona nord-occidentale e del territorio di Novgorod fino al XIV secolo, della zona sud-occidentale e del Granducato di Lituania, della zona sud-orientale e del principato di Ryazan. Le zone dialettali indicano i contatti interdialettali e le modalità con cui si diffondono le tendenze linguistiche. Tutto ciò rende le zone dialettali un fatto essenziale della divisione dialettale.
3. I gruppi di dialetti sono il valore principale della moderna divisione dialettale. I fenomeni dialettali che distinguono gruppi dialettali sono solitamente varietà strutturali di fenomeni presentati negli avverbi e nelle zone dialettali in forma generalizzata, varianti lessico-grammaticali e di formazione delle parole dei fenomeni linguistici dialettali e dei singoli lessemi. La differenza principale tra i gruppi dialettali e gli altri tipi di associazioni linguistico-territoriali è che i gruppi dialettali vengono identificati sulla base dei fenomeni che costituiscono gli anelli del sistema, e non solo sulla somma delle caratteristiche. Pertanto, sono proprio i gruppi di dialetti, in cui la totalità di tutti i fenomeni dialettali e tutti russi sono strutturalmente collegati, a rappresentare i sistemi dei dialetti moderni.
Le isoglosse che distinguono gli avverbi e le zone dialettali formano fasci che presentano differenze significative tra loro. Il territorio in cui si incontrano, intersecandosi, fasci di isoglosse e singole isoglosse di zone dialettali opposte è il territorio dei dialetti interzonali. (I dialetti interzonali situati tra i dialetti settentrionali e meridionali sono anche chiamati dialetti della Russia centrale.)
I confini degli avverbi e delle zone dialettali sono la linea convenzionale di combinazione completa di tutte le aree e dei fenomeni dialettali ad esse caratteristici. Pertanto, i dialetti e le zone dialettali non confinano direttamente tra loro: tra i dialetti si trovano i dialetti della Russia centrale e tra le zone dialettali ci sono i dialetti interzonali.
Una caratteristica dei dialetti interzonali e della Russia centrale è l'assenza in essi di un unico complesso di caratteristiche dialettali uniche per loro.
Conclusioni sul capitolo 1
Pertanto, i dati della geografia linguistica consentono di rispondere a domande su dove, come e in quale sequenza sono apparse determinate varianti linguistiche. Ma la risposta alla domanda su quando sorsero può essere data solo dai monumenti scritti. Molte ricostruzioni nel campo della storia della lingua rimangono ancora ipotetiche a causa della mancanza di monumenti scritti che rispecchino la lingua di diversi territori in diversi periodi storici. In questa situazione, le mappe degli atlanti dialettologici diventano un aiuto significativo per gli storici della lingua. E sebbene riflettano lo stato dei fenomeni dialettali solo nel periodo tardo del loro sviluppo, forniscono tuttavia un quadro completo di tutte le varianti di ciascun fenomeno linguistico nella sua proiezione territoriale. Considerando il fatto che diversi sistemi dialettali riflettono diversi stadi e direzioni di sviluppo del sistema linguistico, sulle mappe linguistiche vediamo una sorta di “diacronia nella sincronia”. È sufficiente che queste informazioni diacroniche possano essere estratte dalle mappe linguistiche.
Non è un caso che uno dei compiti principali della geografia linguistica nella fase attuale sia l'ulteriore sviluppo e miglioramento dei metodi per l'interpretazione storica delle mappe linguistiche.
Tra le opere classiche degli scienziati domestici sulla geografia linguistica, si possono citare le seguenti opere: Avanesov R.I. "Saggi sulla dialettologia russa" (Mosca, 1949), Zhirmunsky V.M. “Su alcuni problemi di geografia linguistica” (M.-L., 1956, 1962); Borodina M.A. “Problemi di geografia linguistica” (M.-L., 1966), Edelman D.I. "Problemi di base della geografia linguistica" (M., 1968), Zakharova K.F., Orlova V.G. “Divisione dialettale della lingua russa” (Mosca, 1970), “Linguistica generale. Metodi di ricerca linguistica" (M., 1973), "Educazione del dialetto della Russia settentrionale e dei dialetti della Russia centrale" (M., 1970), "Studi areali di linguistica ed etnografia" (L., 1983).
Capitolo. Linguistica areale
1.1. Il concetto di “linguistica areale” e le sue caratteristiche
LINGUISTICA AREALE (dal latino area - area, spazio) - una sezione della linguistica che studia utilizzando metodi geografia linguistica fii unioni linguistiche,
dialettologia.
Il concetto centrale della linguistica d'area è un'area linguistica o dialettale, cioè i confini della distribuzione dei singoli fenomeni linguistici e delle loro combinazioni. Il termine “area” viene utilizzato anche per designare i confini della distribuzione delle lingue e delle comunità linguistiche (area indoeuropea, area slava, area turca, ecc.). Nella linguistica areale la distinzione tra piani descrittivi sincronici e diacronici è essenziale. . L'aspetto diacronico è volto a individuare le aree di divisione dello stato protolinguistico e le conseguenti convergenze interdialettali. Questi stati (indoeuropeo comune, slavo comune, turco comune, ecc.) In termini di linguistica areale sono interpretati come uno spazio linguisticamente continuo di dialetti geneticamente correlati, che sono delimitati da isoglosse intersecanti a diversi livelli della struttura linguistica. Il piano sincronico è associato all'istituzione di contatti interdialettali e corrispondenze areali su una sezione cronologica.
Un altro concetto importante della linguistica areale è l'isoglossa; per i diversi livelli vengono utilizzati termini che chiariscono questo concetto: isoglosse fonetiche - isofoni, isoglosse lessicali - isoleks, sviluppo semantico simile - isosemi, ecc. Esistono isoglosse correlate e convergenti; i primi si sviluppano in lingue appartenenti a un'unica comunità genetica; nella loro costituzione vengono utilizzati metodi di ricerca genetica comparata. Le isoglosse convergenti nascono come risultato di contatti territoriali a lungo termine di lingue che formano una comunità areale, o dello sviluppo parallelo di lingue isolate, territorialmente non adiacenti. Le isoglosse di convergenza vengono identificate mediante tecniche di analisi tipologica.
Quando si studiano le ragioni dell'apparizione, la storia dello sviluppo, il fronte e la direzione dell'espansione delle innovazioni e l'identificazione delle aree di conservazione degli arcaismi, un posto importante nella linguistica areale è occupato dalla ricerca del centro, della periferia, delle zone di diffusione (vibrazione) nell'area studiata. È consuetudine distinguere 3 zone principali del continuum del dnaletto: centrale, marginale (zona distante dove le isoglosse osservate sono meno pronunciate) e transitoria. In base a ciò, vengono determinate le aree di distribuzione dei fatti linguistici: innovative, arcaiche e diffuse (di transizione). Nell'individuare innovazioni e arcaismi in L. l. non provengono dal metodo delle norme areali sviluppato dalla scuola italiana di neolinguistica (norma di un'area isolata, norma di un'area periferica, norma di un'area successiva, ecc.). Per lo stato linguistico (dialettale) in esame viene utilizzata la denominazione “paesaggio linguistico (dialettale)”.
2.2. Area storico-culturale: concetto e principi della sua distribuzione
Il concetto di area storico-culturale non ha ricevuto un’adeguata copertura nella sociolinguistica. Nel frattempo, l'attribuzione di alcune lingue della Terra all'una o all'altra area culturale e storica è un fatto indiscutibile. I popoli e, di conseguenza, le loro lingue sono uniti in un'area storico-culturale sulla base del livello generale di sviluppo socio-economico, politico e culturale, sulla comunanza delle tradizioni culturali, sulla base di una certa comunanza dei testi dei libri, che riflette il contenuto principale della parte integrante della cultura spirituale. Un'area storico-culturale è una categoria storica che cambia contenuto, volume e confini in connessione con i cambiamenti nei principi di integrazione, il movimento degli epicentri e la ridistribuzione dei confini tra loro, con il cambiamento e la lotta delle ideologie. L'interazione delle società all'interno di una singola area non si limita solo all'una o all'altra sfera della cultura spirituale, ma è accompagnata da un'interazione più o meno intensa in tutte le sfere della cultura spirituale e materiale, nella vita economica, politica e sociale dell'intero megasocio. Gli ambiti culturali e storici più potenti, che hanno avuto una forte influenza sui destini di molti popoli e delle loro lingue, hanno cominciato a delinearsi nel Medioevo e hanno una storia millenaria. Quindi uno dei principali fattori di integrazione delle aree culturali e storiche che si svilupparono sui territori delle antiche civiltà si rivelò essere la religione.
Fu il Medioevo a dare vita a una categoria speciale di religioni mondiali, che il mondo antico non conosceva. Il contenuto sociale di quest'epoca fu la formazione del sistema feudale. Era lui che aveva bisogno di un'idea speciale della sovrastruttura logica per il suo consolidamento. "Religione E la via di mezzo era un sistema di diritto e una dottrina politica, nonché un insegnamento morale e una filosofia. Era una sintesi di tutte le sovrastrutture sulla base feudale...” [Conrad 1972, 89]. Quelle religioni che, avendo la capacità di adattarsi alle condizioni culturali locali, legavano più strettamente la loro esistenza con lo sviluppo della librezza, con la presenza di testi di libri speciali che sintetizzavano i concetti integrativi della cultura spirituale, acquisirono il maggiore potere integrante. Si sono diffusi non solo nella vicina, ma anche nell'estrema periferia dei corrispondenti epicentri della civiltà. Si tratta del cristianesimo, dell'islam, dell'induismo e del buddismo [Periferia primitiva... 1978, 255 e segg.]. Naturalmente, l'ideologia e i testi corrispondenti non si diffusero da soli, ma con l'aiuto di un'istituzione speciale: la chiesa, che era una potente organizzazione politica con una sottosocietà speciale, il clero, organizzata secondo i principi della gerarchia e della disciplina.
Nella formazione di un'area culturale e storica paneuropea, un ruolo importante ha giocato il cristianesimo, che ha avuto origine in Palestina e si è inizialmente diffuso nella sfera d'influenza della cultura e dell'educazione ellenica dell'ex area culturale e storica ellenica. Nei primi secoli dell'era nuova, il cristianesimo, dopo aver assorbito la ricchezza della tradizione culturale e storica ellenica, si diffuse nei paesi “barbari” che facevano parte dell'Impero Romano o si trovavano alla sua periferia, nell'ambito dei suoi commerci, influenza economica e politica. Negli ultimi cinque secoli fattori socio-economici, politici e culturali hanno contribuito all'espansione di quest'area culturale e storica, che comprendeva l'America, l'Australia, parte dell'Africa e dell'Asia. Le principali fonti di influenza linguistica sono le antiche lingue greca e latina, e nelle fasi iniziali e l'ebraico, nelle fasi successive: inglese, spagnolo, francese, tedesco, nonché slavo del libro e russo. L'importanza storica e l'influenza globale di quest'area culturale e storica sono dovute principalmente al fatto che è all'interno di quest'area che la scienza è nata (l'antica Grecia) e si è sviluppata con successo (l'Europa degli ultimi tre secoli) come uno speciale fenomeno culturale e storico, che fu un fattore potente nello sviluppo della cultura e del linguaggio spirituale. Qui è più evidente lo spostamento del contenuto principale dei principali testi integrativi.
Per quanto riguarda l'area mediorientale, la diffusione della cultura musulmana e della lingua araba come parte integrante di essa nel Nord Africa, nell'Asia occidentale e centrale (a partire dal VII-VIII secolo) incontrò l'ostacolo dell'Etiopia cristiana, della Nubia e di altri regni cristiani . In molti casi queste barriere sono state infrante. Oltre alla lingua principale della cultura islamica, l'arabo, in quest'area hanno avuto un ruolo importante anche la lingua persiana e, in misura minore, lo swahili e alcune altre.
Nel sud dell'Asia si è formata un'area culturale e storica speciale con varie forme di induismo, caratterizzate da una specifica struttura di società di caste. Quest'area allargò i suoi confini durante l'era della creazione dei primi stati indianizzati da parte dei popoli non indo-ariani del sud-est asiatico (antichi Khmer, Mons, Malesi, ecc.) fino a Giava e Sumatra. In questi stati, i titoli indiani, l'etichetta di palazzo indiana, il sanscrito e il pali furono adottati come lingue ufficiali; dalla metà del I millennio, le lingue locali hanno ricevuto la scrittura basata sul sistema di scrittura dell'India meridionale con un enorme strato di prestiti lessicali dal sanscrito. Il ruolo principale qui è stato svolto da varie forme di induismo, che si sono adattate alle istituzioni locali e alle istituzioni che hanno continuato le tradizioni pre-indù: buddismo (Birmania), shaivismo e varie forme di brahmanesimo. Nel nord, l'influenza dell'induismo e del sanscrito si scontra con l'influenza arabo-persiana della vicina area storica e culturale.
L'area orientale di Azpat con l'epicentro culturale Han copre un territorio relativamente piccolo: l'assimilazione profonda di questa cultura è impossibile senza padroneggiare la sua tradizione scritta molto complessa e la struttura specifica della lingua cinese. Inoltre, questa cultura mancava di una religione chiara adatta all'imitazione e all'adattamento alle condizioni e alle tradizioni locali. La percezione della tradizione culturale Han in Corea e Giappone fu facilitata dal fatto che essa si presentava, per così dire, in forma buddista. In tutti i casi in cui le influenze indù e han si sono incontrate ed è emersa un'alternativa: sanscrito o geroglifici, la scelta non è stata fatta a favore di questi ultimi. In Corea e Giappone i geroglifici furono integrati da alfabeti di invenzione locale; in Tibet e Mongolia si diffusero sistemi di scrittura alfabetica di origine indiana e perfino aramaica. In quest’area, la principale fonte di influenza è la Cina e, più recentemente, il Giappone.
Quindi, l'area storico-culturale è una mega-società speciale, capace di includere vari tipi di macro-società, vari stati e popoli, unioni e tribù tribali, in base alla loro interazione sociale nella sfera della cultura spirituale. Tale interazione ha contribuito alla conservazione e all'aumento congiunto del contenuto di una cultura spirituale comune con l'aiuto di istituzioni speciali e dell'interazione linguistica comune. Il mezzo di interazione linguistica è una lingua speciale del libro, comune a tutta l'area del linguaggio come lingua dell'interazione internazionale nella sfera della cultura spirituale. Si presume che il ruolo della lingua principale sia la lingua del libro in cui è stato creato e viene creato il volume più grande di testi di libri, riflettendo il contenuto principale della parte integrante della cultura spirituale e il più importante per l'intero storico-culturale la zona. Il ruolo della lingua principale può essere svolto dall'una o dall'altra lingua, a seconda degli spostamenti nell'epicentro della cultura spirituale e dei cambiamenti nel contenuto principale dei testi integrativi.
La divisione delle lingue (e dei popoli) del mondo in corrispondenti aree culturali e storiche sulla base delle comuni origini storiche della cultura spirituale nel tempo è sempre più riconosciuta come le differenze e le somiglianze delle tradizioni culturali e storiche sostenute da vari tipi di politiche politiche ed economici all’interno dell’area. Il ruolo di quest'ultimo aumenta nel tempo. A ciò si associa la tendenza a creare nuovi habitat su terreni diversi. Lo sviluppo delle relazioni capitaliste stimolò la formazione di sfere anglofone e francofone entro i confini degli ex imperi coloniali. Nei paesi in via di sviluppo, la lingua degli ex colonialisti conserva e, in una certa misura, addirittura rafforza la sua posizione nel campo della scienza e della tecnologia, dell'istruzione specializzata superiore e secondaria. In una lingua, il fenomeno di un'area storico-culturale si manifesta principalmente sotto forma di una comunità di internazionalismi, che consente di proporre il concetto di un fondo lessicale comune per una determinata area.
Un'analisi dell'inventario, della struttura e del comportamento degli internazionalismi in varie lingue ha permesso a V.V. Akulenko di concludere che esistono cinque aree linguistiche principali che coincidono con le aree culturali e storiche sopra elencate [Akulenko 1977, 43]. Naturalmente, il fondo lessicale comune delle lingue dell'area riflette, innanzitutto, la comunanza della cultura spirituale, dell'ideologia, della vita socio-politica, ecc., la comunanza della realtà extralinguistica, per così dire, la comunanza dell'habitat della lingua.
L'alfabeto arabo ha seguito la diffusione dell'Islam e della lingua araba, fungendo da base e modello standard per la creazione della scrittura nelle lingue dei popoli musulmani. Al cristianesimo seguì il principio fonologico della scrittura inventato dai Greci con differenze accettabili nella grafica fino all'invenzione del proprio alfabeto: Wulfila (gotico), Mesrop Mashtots (armeno), Cirillo (antico slavo ecclesiastico), ecc. L'ulteriore sviluppo di la scrittura tra i popoli dell'area culturale e storica europea rifletteva in un modo o nell'altro le differenze religiose. Il contrasto tra l'alfabeto latino e quello cirillico rifletteva la differenza tra le sottoaree dell'Europa occidentale e orientale, storicamente risalente alla differenza tra le chiese romane e bizantine, rivelata nel Concilio del 692 e che portò alla divisione delle chiese nel 1054. il contrasto tra le scritture latina e gotica nella lingua tedesca rifletteva la differenza tra cattolici e protestanti. Il contrasto tra l'alfabeto latino e l'alfabeto “cittadino”, che risale all'alfabeto russo, nella lingua serbo-croata riflette l'antico confine tra l'area culturale e storica dell'Europa occidentale (croati cattolici) e quella dell'Europa orientale (serbi ortodossi). L'ampliamento dei confini dell'area orientale europea portò inizialmente alla creazione di scritte originali, seguendo la tradizione bizantina. Quindi, nel XIV secolo. Stefano di Perm inventò la scrittura originale e tradusse “letture” dal Vangelo, dall'Apostolo, dal Salterio e dal Libro dei Salmi nella lingua zyria (Komi); nel XVI secolo Teodarite inventò la scrittura lappone e tradusse il Vangelo in lappone. Successivamente, sulla base dell'ampio sviluppo della stampa in Russia, furono create scritte basate sulla grafica russa (mordoviana, ecc.). In questo senso, la latinizzazione della scrittura bielorussa nel XIX secolo. e il fallito tentativo di latinizzare la scrittura ucraina rifletteva la lotta ideologica e i tentativi di spostare il confine dell’area dell’Europa occidentale verso est a scapito del territorio ancestrale dell’area culturale e storica dell’Europa orientale. La transizione di alcuni popoli del nostro paese dalla scrittura araba a quella latina e poi alla grafica russa negli anni '30 del XX secolo. riflette l’intenso processo di reintegrazione dei popoli del nostro Paese, l’abbattimento dei vecchi confini tra ex aree culturali e storiche basate su antiche tradizioni religiose.
E questo tratto caratteristico della comunità all'interno dell'area storico-culturale è associato alla comunanza di fondamenti ideologici e tradizioni di cultura spirituale, preservate e trasmesse attraverso i libri e il linguaggio dei libri. Se lo Stato non può esistere senza la scrittura, allora l'area culturale e storica è impensabile senza una lingua libraria guida. Una tale lingua principale rimane uno standard modello per altre lingue che padroneggiano le sfere della cultura spirituale, anche se la lingua principale precedente viene sostituita da una nuova e va in disuso, diventa morta. Il greco antico trasferì presto le sue funzioni come lingua principale del latino medievale, dello slavo librario, del georgiano e di altre lingue, ma fino ad ora il suo contributo a tutte le nuove lingue letterarie che hanno dominato e stanno dominando le sfere della scienza, della filosofia e della cultura vive e si moltiplica.
In specifiche condizioni storiche, qualsiasi lingua del libro è influenzata non da una, ma da diverse tendenze che contribuiscono alla sua integrazione con altre lingue. Ad esempio, la lingua letteraria bulgara si sta sviluppando sotto l'influenza di due tendenze contraddittorie: verso la balcanizzazione e verso la slavizzazione. La fonte della balcanizzazione è la lingua parlata viva, i dialetti bulgari con un certo insieme di caratteristiche linguistiche che caratterizzano l'unione linguistica balcanica. La fonte della slavizzazione è la tradizione letteraria libresca, l'influenza della lingua russa, che è prevalentemente di natura libresca.
La lingua rumena si è sviluppata sotto l'influenza di tre tendenze contraddittorie: balcanizzazione, slavizzazione e romanizzazione. La fonte della balcanizzazione fu il bilinguismo di massa, principalmente romano-slavo. Con l'adozione del cristianesimo, gli antenati dei rumeni e dei moldavi si unirono all'area culturale e storica dell'Europa orientale con la lingua slava del libro che serviva le sfere della cultura spirituale, della chiesa e dell'amministrazione. In questo momento si diffusero i nomi personali del calendario presi in prestito dallo slavo (Vasnliy, Theodor, Mikhail, Gavril, ecc.); i cognomi dei nobili boiardi subirono una significativa slavizzazione attraverso la Polonia e la Lituania. Allo stesso tempo, la lingua russa fu penetrata attraverso il polacco e i cecismi (Aksamita, farmacia ecc.), prima (XI - XIII secolo) - attraverso il libro slavo. Nel XVIII secolo la maggior parte degli europeismi arrivò nella lingua russa attraverso il polacco, allo stesso tempo penetrò un numero significativo di polonismi veri e propri (espressivo, sospettoso, meschino, modesto, inveterato, ragione, argomento, unione Se, avverbio Potere e così via.).
La dinamica del prestito da una lingua all'altra riflette le modalità e la natura delle connessioni tra lingue che fanno parte di un'area culturale e storica comune. Così, nel corso di tre secoli, circa 1000 prestiti dall'inglese penetrarono nella lingua ungherese. All'inizio ce n'erano pochissimi, per tutto il XVII secolo. Solo 5 parole sono state prese in prestito dalla seconda metà del XVIII secolo. il numero dei prestiti dall'inglese attraverso il francese aumentò leggermente, e nel 1820 erano già 90. Durante il periodo di intensa formazione della lingua letteraria ungherese, il numero dei prestiti, principalmente attraverso il tedesco, aumentò a 650. I prestiti di questo periodo riguardano il socio -terminologia politica e tecnica. Nel periodo tra le due guerre (1920-1945), attraverso contatti diretti nel campo dell'economia e del commercio, furono prese in prestito 180 parole, il che si rifletteva nella semantica dei prestiti: il numero dei termini socio-politici e giuridici diminuì significativamente e il volume della produzione e il vocabolario economico è aumentato. Nei primi anni del dopoguerra (1945-1960), ci fu una de-anglizzazione dei prestiti, la sostituzione dei prestiti precedenti con carte da lucido, nonché prestiti dalla lingua russa. Ciò rifletteva da un lato l’indebolimento dei legami ungheresi-britannici e dall’altro il processo di integrazione dei paesi della comunità socialista. Dal 1960 è iniziato un nuovo afflusso di anglicismi, ma si tratta già di internazionalismi che costituiscono il fondo lessicale comune dell'area culturale e storica europea dell'era moderna della rivoluzione scientifica e tecnologica. Si tratta innanzitutto degli internazionalismi che esistono nelle lingue dei popoli dei paesi della comunità socialista.
I confini tra aree culturali e storiche sono fluidi; La reintegrazione delle regioni frontaliere e la lotta degli epicentri per espandere la propria influenza sono in costante svolgimento. Pertanto, la regione di Przemysl sul territorio della Polonia moderna apparteneva in precedenza all'area slava orientale (secoli XI-XIV), ma dopo l'invasione mongolo-tartara questa terra divenne parte della Polonia. Già nei secoli XV-XVI. Qui prevalevano i nomi del calendario russo, anche tra i polacchi (Stepan, Iwan). I nomi polacchi - Grzegorz, Jakub, Macej sono stati trovati meno frequentemente dei corrispondenti russi Grigory, Yakov, Matvey. Dalla fine del XVI secolo. è in corso un intenso processo di sostituzione dei nomi russi con quelli polacchi, accompagnato da un indebolimento del ruolo della Chiesa ortodossa in questa regione.
Durante l'alto medioevo, le terre slave dell'Europa centrale (Pannonia, Grande Moravia, Lusazia) si trovarono sotto l'influenza incrociata di Roma e Bisanzio, fascia di confine tra le aree dell'Europa occidentale e orientale. La missione pannonica di Cirillo e Metodio e la creazione della scrittura slava contribuirono all'annessione di questa regione all'area culturale e storica dell'Europa orientale. L'arresto (870-873) e la morte di Metodio (885) significarono la vittoria del clero tedesco e la completa sottomissione ecclesiastica di questa regione a Roma. Per molti secoli il posto della lingua libraria nativa slava fu preso dal latino. I successivi tentativi di riabilitare la lingua slava non hanno avuto successo per molto tempo. Il monastero di Emaus a Praga, fondato dallo stesso imperatore Carlo IV, non sopravvisse, dove avrebbe dovuto svolgere servizi in slavo librario. Anche il trasferimento dell'arcivescovado a Praga e l'apertura dell'università non riuscirono a rafforzare la posizione della lingua slava. Il tentativo di Jan Hus, rettore dell'Università di Praga, di elevare la lingua slava (ceca) al livello di lingua libraria si è concluso con un incendio che ha consumato sia i coraggiosi libri slavi che quelli slavi.
Il cristianesimo arrivò in Lusazia dalla Repubblica Ceca (X secolo) e portò la terminologia religiosa antico-slava e la lingua libraria slava. Tuttavia, con l'istituzione della sede vescovile a Meissen (968), anche questa regione entrò a far parte dell'area dell'Europa occidentale. L'analisi della terminologia religiosa serba ha dimostrato in modo convincente che su 305 termini, 161 parole sono di origine slava ecclesiastica o ceca antica (njedzela, pjatk, sobota, swajatki, trojica, zakori, hreh, mitosc), alcuni di essi appartengono alla categoria di parole obsolete (cyrkej, djabol , duhowny, kfest, ecc.) E il cristianesimo penetrò in Polonia attraverso i cechi, ma la maggior parte del clero qui era tedesco, francese, italiano; I tedeschi occupavano una posizione dominante nei monasteri polacchi. Il cristianesimo portò molti prestiti latini e tedeschi, caratteristici dell'area culturale e storica dell'Europa occidentale (papez, biskup, aniot, krzyz, msza, ecc.). L'influenza del clero tedesco fu così profonda e pervasiva che fino alla fine del XIV secolo. nella cattedrale principale di Cracovia, Santa Maria, i sermoni non venivano letti in polacco (nella capitale del Regno di Polonia!), ma in tedesco. La lotta tra le aree occidentali e orientali per la regione della Bielorussia e della Lituania, dove il cristianesimo proveniva dalla Rus' di Kiev, fu persistente e di lunga durata. I principi lituani, vedendo l'amaro destino delle tribù prussiane, adottarono inizialmente il cristianesimo secondo il rito orientale. Ma l'espansione dei crociati continuò. La lotta contro un nemico comune (Grunwald) unì le tribù slave e lituane in un unico stato, il Granducato di Lituania, dove la lingua dell'amministrazione statale e della chiesa era la lingua slava lirica. Il clero e la cavalleria tedesca continuarono.I lituani si allontanarono presto dalla zona orientale, convertendosi gradualmente al cattolicesimo.Tuttavia, tracce della prima fase di cristianizzazione si sono conservate nella lingua lituana: angelas "angelo", baznycia, cerkve "chiesa", baznytinis , baznycios "chiesa", grabas "bara", lmyga "libro", krikstyti "battezzare", krikstas “battesimo”, kOmyste “nepotismo”, kunigas “sacerdote”, melsti “pregare”, penktadions “venerdì”, sventas “santo” , ecc. Naturalmente, la composizione principale della terminologia cristiana della moderna lingua lituana risale a una fonte dell'Europa occidentale: popiezius "padre" (romano)", vyskupas "vescovo", kryzius "croce", ecc. Fino al 1386, pari In Lituania i diritti tra cattolici e ortodossi furono mantenuti. A partire dal XV secolo, l'espansione della Chiesa occidentale aumentò notevolmente: fino alla metà del XIX secolo. C'è stata una lotta ostinata tra l'area occidentale per il territorio della Bielorussia. Questa volta i crociati furono sostituiti dai gesuiti, ma l'essenza dell'espansione non cambiò.
La sottomissione a Roma e al clero tedesco avvenne attraverso la Chiesa uniata (Unione di Brest, 1596), che soppiantò ufficialmente l'Ortodossia. Il Concilio di Zamosc del 1720 mise fuori legge la Chiesa ortodossa. In connessione con questo processo, il libro slavo, l'antico bielorusso, la lingua e la stampa cessarono di esistere sul territorio della Bielorussia. Il cattolicesimo continuò la sua avanzata. Questo processo fu sospeso solo nel 1839, quando il vescovo Semashko riunì le chiese ortodosse e uniate della Bielorussia.
A metà del XIX secolo. La stampa di libri bielorussa viene ripristinata con grande difficoltà. L'inizio della sua nuova tappa fu posto dai catechismi “cattolici romani”, stampati in latino secondo l'ortografia polacca (catechismi del 1835 e 1845, pubblicati a Vilna). Nel 1862 fu pubblicato in latino il sillabario bielorusso “dladobrychdzietokka-tolikou”. Secondo l'ortografia polacca in caratteri latini per tutto il XIX secolo. È stata pubblicata la rinascita della narrativa bielorussa (F. Bogushevich, V. Dushsh-Martsinkevich, ecc.). Parallelamente si è sviluppata la stampa russa di libri “cittadini”, sostenuta dal governo russo. Dal 1907, il quotidiano bielorusso “Nasha Shva” è stato pubblicato a San Pietroburgo in due caratteri: latino e “cittadino”. Nel 1911, il giornale organizzò una discussione tra i lettori sui problemi della grafica bielorussa.
La maggioranza si espresse a favore del "cittadino" e dal 1912 "Nasha Shva" passò al carattere russo. Ma già nel 1913 i giornali cattolici “Bielarus” e “Noman” furono pubblicati in latino.
L'area storica e culturale come società gigante assomiglia in qualche modo a uno stato, differendo da quest'ultimo in quanto non è l'interazione amministrativa, ma piuttosto spirituale a determinarne l'integrità. Qui non è tanto la forza militare - un soldato o un cavaliere - quanto le figure della cultura spirituale e dell'ideologia - un prete e un monaco, un insegnante di scuola, un editore di libri, uno scrittore e uno scienziato - che costituiscono il sub- comunità sociale che tutela l’integrità e amplia i confini della propria area culturale e storica. I suoi avamposti sono monasteri e chiese, scuole e tipografie, le sue armi sono la parola, la lettera e il libro. È vero, quando non c'erano abbastanza argomenti, ricorrevano alle armi: gli ordini monastici agivano non tanto con le parole quanto con il fuoco e la spada. I crociati si fidavano maggiormente della spada, i gesuiti si fidavano della scuola e del latino, ma entrambi ricorsero al fuoco: i primi bruciarono villaggi prussiani e slavi, i secondi - libri slavi. Ecco perché lo spostamento dei confini tra aree storiche e culturali influisce principalmente sul destino della lingua, sul destino della stampa dei libri. Ad esempio, uno dei più grandi santuari di importanza pan-greca fu la Pannonia sul Capo Micale (Ionia, Asia Minore), che contribuì all'intensificazione della comunicazione verbale tra tutti i Greci nell'VIII-VI secolo. AVANTI CRISTO e., e soprattutto Ionia. Essendo strettamente connesso con la città principale della Ionia, Mileto, questo territorio fu l'epicentro della formazione del superdialetto commerciale e della Koine pan-greca. Era qui, nella Ionia, nell'VIII secolo. AVANTI CRISTO e., sulla base della comune Koine greca, nacque la scrittura greca antica [Greenbaum 1979]. I Giochi Olimpici (dal 776 a.C.) hanno svolto un ruolo significativo nell'integrazione culturale e linguistica degli antichi greci. Per tutti i greci, Olimpia non era solo una terra sacra con il santuario più autorevole e il pantheon olimpico, ma anche il centro più importante di comunicazione vocale, consolidamento e diffusione della lingua letteraria koinets parlata pan-greca. Lo stadio olimpico ospitava 40-45mila spettatori, gli stadi ateniese ed efesino costruiti successivamente - 60-70mila A proposito, la cessazione dei Giochi Olimpici (393 d.C.) è in un modo o nell'altro collegata alla cessazione delle tendenze di integrazione all'interno dell'area ellenica, con un cambiamento nel suo contenuto ideologico; Il cristianesimo si diffuse, varcando i confini linguistici e territoriali dell'ex mondo ellenico.
Il pellegrinaggio ai “luoghi santi”, agli epicentri della propria cultura spirituale, che a volte assumeva la forma di crociate, cominciò ad agire come un intensificatore della comunicazione verbale nell’area culturale e storica appena creata. Il pellegrinaggio è diffuso in altre aree culturali e storiche ed è uno dei fattori più potenti nell'integrazione e nel rafforzamento delle connessioni interne, nello scambio di valori culturali e nell'intensificazione della comunicazione verbale all'interno dell'area. Il pellegrinaggio alla Mecca e all'area culturale e storica islamica è particolarmente incoraggiato. Il titolo onorifico di hajja ha un carattere e un'autorità musulmana generale: l'hajja è il custode delle informazioni sulle tradizioni della sua zona. L'istituzione dell'hajji fu un fattore significativo nella diffusione e nel consolidamento della lingua araba: per viaggiare attraverso paesi multilingue è necessaria un'unica lingua di comunicazione.
Quindi, la società di un'area storico-culturale è eterogenea e unisce comunità eterogenee ai fini dell'interazione sociale V sfera della cultura spirituale, conservazione e sviluppo del suo contenuto. Distingue una sottosocietà speciale che organizza questa interazione e protegge l'unità interna dell'area (specialisti in vari campi della cultura spirituale). Una tale società comprende diverse socialità eterogenee, servite da diversi linguamamp, non sempre solo imparentati. Allo stesso tempo, si distingue uno speciale socialeme, i cui membri parlano la lingua principale dell'area storico-culturale, la principale (e inizialmente l'unica) lingua del libro, con l'aiuto della quale si svolge l'interazione internazionale nelle sfere della cultura spirituale di questa zona. Il volume di questo socialeme, almeno inizialmente, coincide con il volume della sottosocietà specializzata nel campo dell'ideologia e della cultura spirituale. La riproduzione e l'aumento del suo volume possono essere effettuate solo studiando la lingua del libro a scuola, creando e distribuendo prodotti librari. Potenzialmente il suo volume è limitato solo all’intera area culturale e storica e potrebbe coincidere con il volume dell’intera mega-società. I rappresentanti di questa importante società sono parzialmente, e talvolta completamente, bilingui o diglossi che parlano la lingua principale della loro zona e la loro lingua madre o dialetto.
Altri socialim sono serviti dai dialetti e dalle lingue dei popoli inclusi in questa megasocietà. I potenziali socialem uniscono dialetti e lingue imparentati, entrambi inclusi nell'area culturale e storica e situati al di fuori di essa. Le contraddizioni tra le socialità potenziali e le società che le stanno dietro si manifestano nella lotta per la conservazione di un'unica lingua di cultura spirituale, da un lato, e per l'elevazione della lingua popolare al livello di quella letteraria, capace di servire il sfera della cultura spirituale e dell’ideologia, dall’altro.
Conclusioni sul capitolo 2
La lingua dell'intera area storico-culturale è la lingua del libro, in origine una sola. Funzionava nella sfera dell'ideologia e della cultura spirituale; tutte le altre sfere erano servite da altri linguaggi, inizialmente solo oralmente. La contraddizione funzionale tra le lingue può essere risolta espandendo le funzioni sia della lingua del libro penetrando nella sfera della comunicazione quotidiana in tutta l'area multilingue, sia della lingua popolare nella sfera della cultura spirituale. Di norma prevale il secondo percorso, il percorso per elevare le lingue popolari al livello di quelle letterarie, la formazione di nuove lingue del libro. Il bilinguismo distributivo parziale di una società relativamente ristretta con una rigorosa distribuzione delle funzioni tra la lingua comune dei libri e la lingua popolare orale viene sostituito dal bilinguismo nella sfera della cultura spirituale e dell'ideologia. È attraverso tale bilinguismo che la vecchia lingua del libro cede funzioni di scambio alla nuova lingua di un dato popolo, conservando, almeno inizialmente, le funzioni della lingua dell'interazione internazionale nella sfera della cultura spirituale. Questo processo si riduce alla divergenza di un'unica lingua del libro in diverse nuove lingue letterarie, accompagnata da un processo di convergenza, dalla fusione della lingua popolare con la vecchia lingua del libro. Ogni nuova lingua letteraria è una sorta di ibrido tra la lingua poetica popolare orale e la lingua del libro di una determinata area storico-culturale; eredita tutti gli attributi del linguaggio del libro: la natura della scrittura, della grafica, dei mezzi visivi, dei concetti. Il modo principale per trasferire tale patrimonio dalla vecchia lingua del libro alle nuove lingue letterarie sono le traduzioni. Nel caso della ridistribuzione dei confini tra aree culturali e storiche, i processi convergenti coprono tutte le lingue letterarie dell’area, con il ruolo dominante svolto principalmente dalla lingua della comunicazione internazionale nella sfera della cultura spirituale e dell’ideologia.
Conclusione
La dialettologia nella fase attuale non può essere immaginata senza l'uso del metodo della mappatura dei fatti linguistici. Lo sviluppo di questo metodo ha portato alla creazione di un ramo speciale della dialettologia: la linguisticogeografia, la scienza dei modelli nella distribuzione territoriale dei fenomeni linguistici. La geografia linguistica è una scienza relativamente nuova. Ha avuto origine in Europa alla fine del XIX secolo. Lo scienziato tedesco G. Venker e il linguista francese J. Gillieron avviarono un'apposita indagine linguistica del territorio con lo scopo di presentare successivamente il materiale dialettale raccolto su carte geografiche. I primi risultati della linguisticogeografia sono associati ai nomi di questi scienziati e hanno anche contribuito alla formulazione dei suoi concetti di base.
Nel 1876 in Germania Georg Wenker(1852-1911) iniziò a raccogliere materiale per compilare un atlante linguistico della lingua tedesca, prestando particolare attenzione ai fenomeni fonetici e grammaticali. Nel 1926 furono pubblicate alcune mappe. In Francia nel 1902-1910. Jules Gilleron(1854-1926) e Edmond Edmond (1848-1926) crearono Atlante linguistico Francia, prestando attenzione alle caratteristiche lessicali. Poi iniziarono ad apparire atlanti linguistici in Italia, Romania, Spagna e Svizzera.
In Russia nel 1903, su iniziativa di A.A. Shakhmatov, fu creata la Commissione dialettologica di Mosca, che nel 1915 pubblicò Esperienza di una carta dialettologica della lingua russa in Europa. Questo è stato il primo tentativo di mappatura linguistica dei dialetti delle lingue slave orientali.
Lo sviluppo della geografia linguistica in Russia si basa sulle tradizioni della dialettologia russa. Nel 1903 fu creato su iniziativa di A.A. Commissione dialettologica Shakhmatov di Mosca, che pubblicò nel 1915 “L’esperienza di una mappa dialettologica della lingua russa in Europa”. Questa è stata la prima esperienza di mappatura linguistica dei dialetti delle lingue slave orientali, in cui è stata proposta una classificazione e un raggruppamento di questi dialetti e sono stati presentati i confini della divisione dialettale della lingua russa. L'ulteriore sviluppo della geografia linguistica russa è collegato alle opere di R, I, Avanesov e dei suoi studenti a Mosca, nonché alle opere dei linguogeografi di Leningrado (V.M. Zhirmunsky, B.A. Larin, F.P. Filin, ecc.).
Le disposizioni generali della geografia linguistica in Russia sono esposte nel libro “Domande sulla teoria della geografia linguistica” (1962). Questa teoria si basa sul concetto di differenza dialettale sviluppato da Avanesov come elemento della struttura della lingua, che in diversi sistemi dialettali particolari appare nelle sue diverse varianti correlative, ciascuna di queste varianti è un elemento di un sistema dialettale separato, e la la totalità di queste varianti forma differenze dialettali intersistemi. Pertanto, quest'ultimo è sempre binomiale o polinomiale, e i membri della differenza dialettale intersistema sono in un rapporto naturale tra loro, si escludono a vicenda in un sistema dialettale e si sostituiscono a vicenda in sistemi diversi.
Questa comprensione delle differenze dialettali e della sua struttura si basa su una comprensione generale della lingua non come una semplice somma di dialetti, ma come un sistema complesso che include sia elementi comuni all'intera lingua sia elementi privati e distintivi che caratterizzano i singoli dialetti. Pertanto non sono i fatti isolati della lingua ad essere oggetto di mappatura, ma i fenomeni linguistici come elementi del sistema linguistico.
L'attuazione pratica di queste idee trovò espressione nello sviluppo iniziato a metà degli anni '40. 20 ° secolo lavorare alla creazione di un atlante dialettologico della lingua russa. Sulla base del "Questionario per la compilazione di un atlante dialettologico della lingua russa" (1940), fu creato un atlante di prova di un piccolo territorio - "Atlante linguistico della regione del lago Seliger", pubblicato nel 1949. La Grande Guerra Patriottica interruppe il lavoro dialettologico nella Russia sovietica, ma già alla fine del 1944. Una nuova fase di lavoro sull'atlante iniziò presso l'Istituto di lingua russa dell'Accademia delle scienze dell'URSS. Nel 1945 fu pubblicato il "Programma per la raccolta di materiali dizionari per la compilazione di un atlante dialettologico della lingua russa", secondo il quale iniziarono a lavorare molte spedizioni dialettologiche di università, istituti pedagogici e istituzioni scientifiche. Nel 1957 fu pubblicato l'Atlante dei dialetti popolari russi delle regioni centrali a est di Mosca. All'inizio degli anni '80. è stato creato un consolidato "Atlante dialettologico della lingua russa" (vol. 1-3), sono stati creati atlanti delle lingue ucraina, bielorussa e moldava.
Nel 1958 iniziarono i lavori sull’Atlante linguistico slavo comune, al quale presero parte linguisti di tutti i paesi slavi e di alcuni altri stati europei in cui vivono gli slavi. La direzione generale appartiene alla Commissione internazionale degli slavi. Nel 1978 fu pubblicato il numero introduttivo dell'Atlante linguistico slavo comune, contenente vari materiali di riferimento, nel 1988 - il primo numero fonetico e di formazione delle parole; Proseguono i lavori sull’“Atlante linguistico slavo comune”.
Nel 1975 la Russia ha aderito all’organizzazione internazionale “Atlante Linguistico d’Europa”, il centro si trova in Italia. Linguisti di tutti i paesi europei stanno lavorando a questo atlante, che copre tutte le lingue europee, correlate e non correlate, multi-sistema. Per raccogliere i materiali sono stati compilati due questionari. Sono state pubblicate due edizioni dell’“Atlante linguistico dell’Europa” (1983-86)
La linguistica areale è una branca della linguistica che studia utilizzando metodi geografia linguistica fii distribuzione dei fenomeni linguistici nell'estensione spaziale e nell'interazione interlinguistica (interdialetto). Il principio determinante nella descrizione areale dei fatti delle lingue interagenti (dialetti) è la loro copertura frontale. Il compito principale della linguistica areale è caratterizzare la distribuzione territoriale delle caratteristiche linguistiche e interpretare le isoglosse. Di conseguenza si individuano ambiti (ambiti) di interazione tra dialetti, lingue e comunità areali – unioni linguistiche, caratterizzati da caratteristiche strutturali comuni.
Il termine "linguistica spaziale/areale" fu introdotto per la prima volta da M. J. Bartoli e G. Vidossi (1943), ma i suoi principi di base furono sviluppati da Bartoli nel 1925. La linguistica areale è strettamente correlata alla linguistica. geografia e dialettologia. Esplora la correlazione dei fenomeni, la direzione e le aree della loro distribuzione in un certo numero di lingue, mentre la dialettologia fornisce una descrizione della struttura del dipartimento. lingua nella sua versione territoriale. Allo stesso tempo, gli studi dialettologici servono da vicino come base fattuale della linguistica areale.
Il concetto centrale della linguistica d'area è un'area linguistica o dialettale, cioè i confini della distribuzione dei singoli fenomeni linguistici e delle loro combinazioni. Il termine “area” viene utilizzato anche per designare i confini della distribuzione delle lingue e delle comunità linguistiche (area indoeuropea, area slava, area turca, ecc.).
Pertanto, in questo lavoro abbiamo esaminato i concetti di base della geografia linguistica e di un ramo correlato della linguistica, la linguistica areale, e abbiamo mostrato la storia dello sviluppo della geografia linguistica. Abbiamo parlato dei metodi di queste scienze, dei risultati pratici della geografia linguistica in Russia e all'estero (mappe linguistiche e atlanti). È stato dato il concetto di area storico-culturale (principalmente utilizzando l'esempio della diffusione della lingua slava del libro). Vengono mostrate anche la divisione dialettale della lingua russa e la sua fissazione sulle mappe linguistiche dialettologiche.
Bibliografia
1. Berezin F.M., Golovin B.N. Linguistica generale. M.: Educazione, 1979.
2. Vinogradov V.V. Storia degli insegnamenti linguistici russi. M., 1978. – 317 pag.
3. Girutsky A.A. Linguistica generale. Minsk: Logos, 2001. – 207 pag.
4. Golovin B.N. Introduzione alla linguistica. M., 1983.
5. Zhuravlev V.K. Fattori esterni ed interni dell'evoluzione del linguaggio. M., Progetto, 1982. – 312 p.
6. Ivanova Z.A. Segreti della lingua madre. Volvograd, 1969.
7. Kodukhov V.I. Linguistica generale. – M., 1974.
8. Levitsky Yu.A., Boronnikova N.V. Storia degli insegnamenti linguistici. M.: Logos, 2005. – 246 p.
9. Otkupshchikov Yu.V. Alle origini della parola. – M., 1986.
10. Dialettologia russa / ed. LL. Kasatkina. – M.: Academia, 2005. – 288 p.
11. Stepanov Yu.S. Fondamenti di linguistica generale. M., 1975.
12. Uspensky L.V. Una parola sulle parole. Perché non altrimenti? L., 1979.
13. Linguistica: ampio dizionario enciclopedico/redattore capo. V.N. Yartseva. – 2a ed. – M.: Grande Enciclopedia Accademica, 2000. – 688 p.